 Torniamo ancora una volta sul tema del museo, per completare il resoconto della seconda giornata del convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom. Condotta da Daniele Jalla con Elena Romagnolo, la tavola rotonda del pomeriggio ha visto la proposta di alcuni binomi, elaborati a partire da uno studio condotto sui musei moderni e del Novecento; termini di confronto che non si danno – ha detto Jalla – come alternativi bensì come “dilemmi e tensioni” che i musei, e chi se ne occupa, devono affrontare. Non si tratta, per lo più, di termini nuovi, ma il loro abbinamento genera nodi da cui sorgono e in cui si intersecano numerosi quesiti ancora da risolvere. (Anche in questo caso ciò che riporto non sono sempre citazioni letterali, ma il senso di quanto sentito, come da me inteso; spero correttamente.)In situ / In museo: centro della riflessione sono gli oggetti che, sottratti al loro contesto, vengono introdotti nel museo dove, perdendo il loro valore d’uso, mantenendo un valore di scambio e assumendo un valore simbolico, devono tuttavia proprio documentare quella realtà e quel contesto da cui sono stati separati. Come il museo deve ricostruire il contesto originario? Quali sono, nella storia del museo, le soluzioni adottate per ricostruire il rapporto con tale contesto? Secondo quali gradi? E ancora, a quale tipo di intenzione comunicativa il museo deve rifarsi? Quale bagaglio culturale deve essere colmato: quello del curatore o quello della cultura che ha prodotto quegli oggetti? Come tenere insieme la delocalizzazione e il mantenimento in situ degli oggetti musealizzati?Collezione / Museo: se il museo non è da intendersi solo come raccolta di cose ma come soggetto, ovvero istituzione, allora si può dire che quel che precede il museo moderno è piuttosto “collezione” (privata o pubblica) che museo vero e proprio. Al tempo stesso la persistenza, ancora oggi, di molte collezioni impone di chiedersi come distinguere quelle che sono tali e quelle che possono essere (o sono) musei.Enciclopedico / Disciplinare: se “enciclopedico” storicamente si riferisce a un periodo e a una concezione precisi, quel che qui s’intende è il museo “che tutto contiene” in quanto distinto da quello invece disciplinare. Da universale ed enciclopedico, infatti, il museo moderno passa a essere sempre più disciplinare, dando così luogo a categorie e tipologie museali distinte non tanto in base alle collezioni quanto in relazione alla disciplina (accademica) di riferimento. Del resto il museo non solo esprime un paradigma disciplinare bensì può essere il luogo in cui si elabora e propone una definizione.Disciplinare / Tematico: è questo un binomio o passaggio su cui Jalla ha voluto particolarmente concentrarsi; al carattere disciplinare del museo moderno, infatti, si “oppone” oggi la tendenza verso il tematico, che significa interdisciplinarità, forse anche come tentativo di attuare una ricomposizione dei saperi. Certo è che il criterio tematico è quello che usualmente connota le mostre, le esposizioni temporanee; tuttavia è indubbio che anche i musei mostrino una forte propensione in questo senso. E probabilmente è pure una modalità per accogliere in sede istituzionale tutto ciò che si pone al “confine”, quel che non rientra in distinzioni disciplinari che non reggono più. D’altronde, dove, se non nel museo, proporre la ricomposizione dei saperi?È stato questo un punto abbastanza discusso, ma Jalla ha precisato come – più che di una proposta – si tratti di una presa d’atto di quel che già sta avvenendo («a un certo punto non c’è più il museo di scienze naturali ma il “museo dell’acqua”»), di realtà che vale la pena di esaminare per cercare di cogliere il mutamento in corso, magari anche interrogandosi se il termine “museo” sia ancora valido o sia usato per comodità, se si stiano producendo alternative inedite.Formazione / Educazione: oltre le finalità educative, è forse possibile o consigliabile recuperare il museo didattico di stampo ottocentesco, inteso non come educativo del “gusto” ma come tenuto in relazione con gli ambienti accademico-universitari, quindi come luogo in cui passa la formazione, per esempio, dei quadri industriali o degli artisti ecc. Pensare nuovamente a una pedagogia basata sulle cose, sugli oggetti, non relegandola a esperienza conclusa, che giace nella storia della museografia. Una pedagogia, inoltre, che non trascuri quel “diletto” di cui parla la definizione Icom, perché museo c’è solo laddove educazione e diletto si diano congiuntamente (con diletto che non significa loisir, non è la superficialità dei dispositivi comunicativi, bensì sgorga direttamente dalle finalità dell’istituzione).Nazionale / Locale: se i primi musei moderni sono nazionali, non solo in quanto collocati nelle capitali o maggiori città dei vari stati, ma perché espressione di una memoria e strumenti per la costruzione di una identità che si vogliono “nazionali”, a essi ben presto si sono aggiunti musei a carattere locale. Quella che si propone con questo binomio è la riflessione su come il locale si integri o possa integrare con il livello nazionale, come possa costituirne una articolazione, per esempio sul modello dei depôts francesi o dei musei civici italiani.Locale / Globale: dopo gli anni settanta del Novecento, “locale” è stato però soprattutto inteso non in relazione a “nazionale” bensì come termine contrapposto ai montanti movimenti e processi di globalizzazione. Tre quarti dei musei sorti negli ultimi cinquant’anni riflettono una esplosione di locale vs “tutto il resto del mondo”.Strumento / Ornamento: è una opposizione che si trova presto nei musei, che infatti nascono per lo più come strumenti di prestigio, dunque ornamento, oppure come strumento di educazione, o strumento tout court. Da un lato quindi è possibile insistere verso una istituzione rispetto alla quale poco importa chiedersi a cosa serva, purché “faccia fare bella figura”; dall’altro, per contro, si può insistere sulla qualità diversamente strumentale, dove l’utilità è formativa ma anche, in senso più ampio, culturale e sociale.Comunità / Territorio: premesso che se “territorio” viene limitato al dato geografico, se non viene incluso il patrimonio, il termine è presso che inservibile, la tensione qui in gioco è appunto quella fra museo che ponga l’accento sul patrimonio-territorio e il museo “comunitario”, la cui origine è strettamente connessa al pensiero, alla gestione e alla fattiva produzione da parte della comunità.Comunità / Collettività: qui il binomio sposta l’accento ora sulla comunità concreta, cui appartiene il museo e alla quale il museo fa riferimento, e la collettività intesa come destinatario in senso più largo, il pubblico a cui si rivolge lo sforzo comunicativo del museo, il suo contenuto.Permanente / Temporaneo: Krzysztof Pomian ha scritto che caratteristica del museo è la permanenza dell’istituzione; anche gli oggetti e gli allestimenti possono essere tali. La crescita delle collezioni pone tuttavia di fronte al problema di un diverso rapporto fra collezioni ed esposizione: è necessario operare scelte e trovare soluzioni nuove, in cui si apre la distinzione fra permanente (collezione) e temporaneo o soggetto al mutamento (allestimento). Oltre ciò, oggi soprattutto, “temporaneo” può anche diventare uno strumento aggiuntivo per il museo, inteso come mostre che possono essere curate e organizzate sia per esplorare il patrimonio sia come eventi indipendenti, esterni al posseduto museale.Reale / Virtuale: al museo delle cose si affianca il museo delle idee, in cui la presenza di realtà virtuali si aggiunge e talora sostituisce agli oggetti. Sempre meno museo, quindi, e sempre più spazio di comunicazione? Il bilanciamento fra i due poli è una questione cruciale – e infatti i presenti alla tavola rotonda si sono soffermati non poco su questo tema, cercando di precisarne il senso. Come abbiamo già detto, per esempio, Maria Gregorio ha ricordato che finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi.Accessibilità / Partecipazione: molto nei musei è stato fatto per assicurare e favorire l’accessibilità da parte del pubblico; il punto più alto, però, è stato detto, potrebbe essere raggiunto con la partecipazione attiva del visitatore, non solo in quanto può rientrare nella comunità da cui il museo nasce, ma in quanto si faccia interprete partecipe (con qualche riferimento alla “morte dell’autore”, che poi sarebbe il curatore, il museografo).Dopo aver registrato gli interventi dei relatori, che hanno sicuramente testimoniato come attorno a questi binomi – ma non solo questi – si possono e devono avviare ulteriori riflessioni ed elaborazioni, Daniele Jalla, traendo le conclusioni, ha osservato come l’intento non sia tanto porre parole o cesure definitive, quanto piuttosto assumere consapevolmente che il museo moderno, quello che ci è stato consegnato dopo la rivoluzione francese e che ha avuto tanta storia fino a oggi, si trova in bilico, pro-teso verso qualcosa di nuovo; e che, a quanto pare, anche le numerose e intense discussioni degli anni sessanta-settanta, forse, non hanno provocato rispetto al passato un vero e proprio cambiamento, semmai solo qualche oscillazione. Questi binomi sono dunque la lente attraverso cui guardare le problematiche del presente, percorsi da intraprendere senza attendersi direzioni univoche ma possibilità di analisi, che aiutino quanti si occupano di musei nel chiarimento verso se stessi e verso l’“esterno”, sia esso costituito da cittadini, politici, amministratori ecc.
Torniamo ancora una volta sul tema del museo, per completare il resoconto della seconda giornata del convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom. Condotta da Daniele Jalla con Elena Romagnolo, la tavola rotonda del pomeriggio ha visto la proposta di alcuni binomi, elaborati a partire da uno studio condotto sui musei moderni e del Novecento; termini di confronto che non si danno – ha detto Jalla – come alternativi bensì come “dilemmi e tensioni” che i musei, e chi se ne occupa, devono affrontare. Non si tratta, per lo più, di termini nuovi, ma il loro abbinamento genera nodi da cui sorgono e in cui si intersecano numerosi quesiti ancora da risolvere. (Anche in questo caso ciò che riporto non sono sempre citazioni letterali, ma il senso di quanto sentito, come da me inteso; spero correttamente.)In situ / In museo: centro della riflessione sono gli oggetti che, sottratti al loro contesto, vengono introdotti nel museo dove, perdendo il loro valore d’uso, mantenendo un valore di scambio e assumendo un valore simbolico, devono tuttavia proprio documentare quella realtà e quel contesto da cui sono stati separati. Come il museo deve ricostruire il contesto originario? Quali sono, nella storia del museo, le soluzioni adottate per ricostruire il rapporto con tale contesto? Secondo quali gradi? E ancora, a quale tipo di intenzione comunicativa il museo deve rifarsi? Quale bagaglio culturale deve essere colmato: quello del curatore o quello della cultura che ha prodotto quegli oggetti? Come tenere insieme la delocalizzazione e il mantenimento in situ degli oggetti musealizzati?Collezione / Museo: se il museo non è da intendersi solo come raccolta di cose ma come soggetto, ovvero istituzione, allora si può dire che quel che precede il museo moderno è piuttosto “collezione” (privata o pubblica) che museo vero e proprio. Al tempo stesso la persistenza, ancora oggi, di molte collezioni impone di chiedersi come distinguere quelle che sono tali e quelle che possono essere (o sono) musei.Enciclopedico / Disciplinare: se “enciclopedico” storicamente si riferisce a un periodo e a una concezione precisi, quel che qui s’intende è il museo “che tutto contiene” in quanto distinto da quello invece disciplinare. Da universale ed enciclopedico, infatti, il museo moderno passa a essere sempre più disciplinare, dando così luogo a categorie e tipologie museali distinte non tanto in base alle collezioni quanto in relazione alla disciplina (accademica) di riferimento. Del resto il museo non solo esprime un paradigma disciplinare bensì può essere il luogo in cui si elabora e propone una definizione.Disciplinare / Tematico: è questo un binomio o passaggio su cui Jalla ha voluto particolarmente concentrarsi; al carattere disciplinare del museo moderno, infatti, si “oppone” oggi la tendenza verso il tematico, che significa interdisciplinarità, forse anche come tentativo di attuare una ricomposizione dei saperi. Certo è che il criterio tematico è quello che usualmente connota le mostre, le esposizioni temporanee; tuttavia è indubbio che anche i musei mostrino una forte propensione in questo senso. E probabilmente è pure una modalità per accogliere in sede istituzionale tutto ciò che si pone al “confine”, quel che non rientra in distinzioni disciplinari che non reggono più. D’altronde, dove, se non nel museo, proporre la ricomposizione dei saperi?È stato questo un punto abbastanza discusso, ma Jalla ha precisato come – più che di una proposta – si tratti di una presa d’atto di quel che già sta avvenendo («a un certo punto non c’è più il museo di scienze naturali ma il “museo dell’acqua”»), di realtà che vale la pena di esaminare per cercare di cogliere il mutamento in corso, magari anche interrogandosi se il termine “museo” sia ancora valido o sia usato per comodità, se si stiano producendo alternative inedite.Formazione / Educazione: oltre le finalità educative, è forse possibile o consigliabile recuperare il museo didattico di stampo ottocentesco, inteso non come educativo del “gusto” ma come tenuto in relazione con gli ambienti accademico-universitari, quindi come luogo in cui passa la formazione, per esempio, dei quadri industriali o degli artisti ecc. Pensare nuovamente a una pedagogia basata sulle cose, sugli oggetti, non relegandola a esperienza conclusa, che giace nella storia della museografia. Una pedagogia, inoltre, che non trascuri quel “diletto” di cui parla la definizione Icom, perché museo c’è solo laddove educazione e diletto si diano congiuntamente (con diletto che non significa loisir, non è la superficialità dei dispositivi comunicativi, bensì sgorga direttamente dalle finalità dell’istituzione).Nazionale / Locale: se i primi musei moderni sono nazionali, non solo in quanto collocati nelle capitali o maggiori città dei vari stati, ma perché espressione di una memoria e strumenti per la costruzione di una identità che si vogliono “nazionali”, a essi ben presto si sono aggiunti musei a carattere locale. Quella che si propone con questo binomio è la riflessione su come il locale si integri o possa integrare con il livello nazionale, come possa costituirne una articolazione, per esempio sul modello dei depôts francesi o dei musei civici italiani.Locale / Globale: dopo gli anni settanta del Novecento, “locale” è stato però soprattutto inteso non in relazione a “nazionale” bensì come termine contrapposto ai montanti movimenti e processi di globalizzazione. Tre quarti dei musei sorti negli ultimi cinquant’anni riflettono una esplosione di locale vs “tutto il resto del mondo”.Strumento / Ornamento: è una opposizione che si trova presto nei musei, che infatti nascono per lo più come strumenti di prestigio, dunque ornamento, oppure come strumento di educazione, o strumento tout court. Da un lato quindi è possibile insistere verso una istituzione rispetto alla quale poco importa chiedersi a cosa serva, purché “faccia fare bella figura”; dall’altro, per contro, si può insistere sulla qualità diversamente strumentale, dove l’utilità è formativa ma anche, in senso più ampio, culturale e sociale.Comunità / Territorio: premesso che se “territorio” viene limitato al dato geografico, se non viene incluso il patrimonio, il termine è presso che inservibile, la tensione qui in gioco è appunto quella fra museo che ponga l’accento sul patrimonio-territorio e il museo “comunitario”, la cui origine è strettamente connessa al pensiero, alla gestione e alla fattiva produzione da parte della comunità.Comunità / Collettività: qui il binomio sposta l’accento ora sulla comunità concreta, cui appartiene il museo e alla quale il museo fa riferimento, e la collettività intesa come destinatario in senso più largo, il pubblico a cui si rivolge lo sforzo comunicativo del museo, il suo contenuto.Permanente / Temporaneo: Krzysztof Pomian ha scritto che caratteristica del museo è la permanenza dell’istituzione; anche gli oggetti e gli allestimenti possono essere tali. La crescita delle collezioni pone tuttavia di fronte al problema di un diverso rapporto fra collezioni ed esposizione: è necessario operare scelte e trovare soluzioni nuove, in cui si apre la distinzione fra permanente (collezione) e temporaneo o soggetto al mutamento (allestimento). Oltre ciò, oggi soprattutto, “temporaneo” può anche diventare uno strumento aggiuntivo per il museo, inteso come mostre che possono essere curate e organizzate sia per esplorare il patrimonio sia come eventi indipendenti, esterni al posseduto museale.Reale / Virtuale: al museo delle cose si affianca il museo delle idee, in cui la presenza di realtà virtuali si aggiunge e talora sostituisce agli oggetti. Sempre meno museo, quindi, e sempre più spazio di comunicazione? Il bilanciamento fra i due poli è una questione cruciale – e infatti i presenti alla tavola rotonda si sono soffermati non poco su questo tema, cercando di precisarne il senso. Come abbiamo già detto, per esempio, Maria Gregorio ha ricordato che finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi.Accessibilità / Partecipazione: molto nei musei è stato fatto per assicurare e favorire l’accessibilità da parte del pubblico; il punto più alto, però, è stato detto, potrebbe essere raggiunto con la partecipazione attiva del visitatore, non solo in quanto può rientrare nella comunità da cui il museo nasce, ma in quanto si faccia interprete partecipe (con qualche riferimento alla “morte dell’autore”, che poi sarebbe il curatore, il museografo).Dopo aver registrato gli interventi dei relatori, che hanno sicuramente testimoniato come attorno a questi binomi – ma non solo questi – si possono e devono avviare ulteriori riflessioni ed elaborazioni, Daniele Jalla, traendo le conclusioni, ha osservato come l’intento non sia tanto porre parole o cesure definitive, quanto piuttosto assumere consapevolmente che il museo moderno, quello che ci è stato consegnato dopo la rivoluzione francese e che ha avuto tanta storia fino a oggi, si trova in bilico, pro-teso verso qualcosa di nuovo; e che, a quanto pare, anche le numerose e intense discussioni degli anni sessanta-settanta, forse, non hanno provocato rispetto al passato un vero e proprio cambiamento, semmai solo qualche oscillazione. Questi binomi sono dunque la lente attraverso cui guardare le problematiche del presente, percorsi da intraprendere senza attendersi direzioni univoche ma possibilità di analisi, che aiutino quanti si occupano di musei nel chiarimento verso se stessi e verso l’“esterno”, sia esso costituito da cittadini, politici, amministratori ecc.
Month: June 2007
Museo
Musei?
Questione di lessico, ma non solo…
 Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.
Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.
Il telescopio di Proust
ovvero: Marcel ritrovato
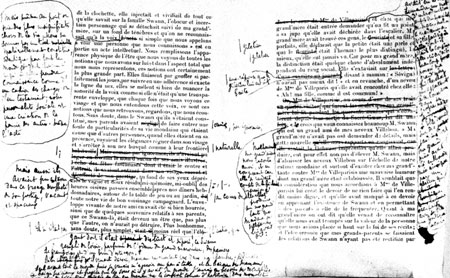 Qualche tempo fa, attraverso la lettura di Franco Rella, Il silenzio e le parole, Feltrinelli, Milano 2001, ci è accaduto di ritrovare un brano del Tempo ritrovato di Marcel Proust, ivi ripreso con riferimento a Walter Benjamin e particolarmente interessante per la consonanza “metodologica” che per noi evoca. Ma teniamolo in serbo un poco, e seguiamo come recentemente vi siamo tornati con gran conforto.Pochi giorni fa, attraverso la lettura del saggio di James A. Boon, Perché i musei mi mettono tristezza, in Politiche e politiche dell’allestimento museale, a cura di Ivan Karp, Steven D. Lavine, introduzione di Fredi Drugman, Clueb, Bologna 1995, ci siamo imbattuti in un’altra (non necessariamente nel senso di una alternativa escludente) lettura di Proust, che segue la citazione (ivi, p. 154) di Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, pp. 145-146, ovvero 1995, p. 151, là dove parla delle illustrazioni di Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard) che, proprio nell’epoca delle esposizioni universali, rappresenta «oggetti morti» che «si depositano chiaramente nella spécialité – una qualifica o etichetta che sorge in questo periodo dell’industria di lusso; sotto la matita di Grandville la natura intera si trasforma in spécialités. Egli la presenta nello stesso spirito in cui la réclame – anche questa parola sorge in questo periodo – comincia a presentare i suoi articoli. Finisce pazzo».Ma non perdiamo di vista Proust – fra l’altro passeremo per Venezia.Scrive infatti Boon (ivi, pp. 155 ss): «Potete visitare L’Aia (deux étoiles), entrare nel museo Mauritshuis (trois étoiles) sedere con devozione davanti alla veduta di Delft di Vermeer e ascoltare i visitatori francesi recitare, come a memoria, non Proust su Vermeer ma la citazione nella Guida Michelin delle parole del Narratore della Recherche su Vermeer, che può essere la cosa giusta da recitare in questo genere di visite. Io stesso ho avuto modo di sentire più volte, intonata dai visitatori, questa appropriata didascalia, tratta da una guida non precisamente banale: “le plus beau tableau du monde”. Questo saccheggio di Proust da parte del Guide Miche è stato a sua volta saccheggiato dai visitatori, che recitano a voce alta il panegirico, senza preoccuparsi troppo dell’altro visitatore che, lì accanto, vorrebbe leggere in silenzio la Veduta di Vermeer […]. Ora, per quanto mi è stato possibile capire, origliando, questa attività non ha reso i passanti francesi a loro volta melanconici, e neppure allegri, peraltro. Ma chissà. Questi ritmi di riappropriazione resero comunque Proust, o il suo Narratore, triste, o melanconico, o incline alla musica o consapevole della necessità per la memoria di nutrirsi di strati di frammentarie leggende di residui del passato e di luoghi già frammentati e etichettati – come i musei. Proprio questo era la prosa di Proust, e dei suoi predecessori: saccheggio di saccheggio di saccheggio [ma, vorremmo aggiungere, con quale altezza e onestà!].Proust fece oggetto di saccheggio e di “pastiche” [in specie con Pastiches et mélanges] un gran numero di prosatori, compreso Ruskin, di cui addirittura tradusse Sesame and Lillies, scoprendo così una vocazione a scrivere secondo una memoria accumulativa che non si riduceva a una semplice rievocazione [per chiudere il cerchio si dovrebbe ricordare che Benjamin, per parte sua, tradusse Proust]. Tra le opere di Ruskin che Proust saccheggiò su suggerimento della madre c’erano le famose verbalizzazioni e visualizzazioni che suscitavano un vivo senso del luogo e del tempo con riferimento a quello che è forse il luogo più saccheggiato sulla terra: Venezia. […] La museificazione di Venezia a opera di Ruskin, da una parte, la salvò da un certo tipo di concezione turistica (quella che in precedenza l’aveva salvata) e, dall’altra, lanciò una nuova maniera e un nuovo stile di gustare-Venezia che nelle epoche successive l’avrebbe salvata più e più volte. E Venezia non è mai rimasta quel che era. E non si può neppure dire che la stessa Venezia (sposa del mare) non possa essere accusata di saccheggio e sfruttamento. La città cominciò a costituirsi in museo, o più precisamente in reliquiario, molti secoli prima che i viaggiatori e i voyeurs lettori di Ruskin insieme trasformassero Venezia in un composito emblema politico-estetico, con la speranza di redimere l’Europa industriale. […] Se mai una città era destinata a finir museificata – e in un certo senso tutte possono esserlo – quella fu proprio Venezia. Quando il Narratore di Proust descrive Venezia, lo fa sulla scia di una catalogazione che si vuole esaustiva come quella di Ruskin […]». E con riferimento ai ricordi involontari proustiani, scrive Boon (ivi, p. 159): «il narratore finisce col riconoscere nelle sue anticipazioni come nei suoi ricordi i mediatori dell’“esperienza”; più precisamente, ogni esperienza pura sarebbe tesa tra i poli irriducibili dell’anticipazione del ricordo, ed è proprio questa tensione che il narratore finisce col descrivere».Ora, di fronte a questo Proust saccheggiatore e accumulatore, abbiamo ripreso in mano il testo di Rella, Il silenzio e le parole, cit., p. 148, che ricorda le affinità quasi esistenziali fra Benjamin e Proust – «la malattia, il riso, il collezionismo: anche delle “reliquie della memoria”» – ma soprattutto come il primo assumesse nelle opere della maturità il modello teorico proustiano: «Nell’Opera d’arte nell’età della sua riproducibilità tecnica, la distruzione dell’aura, che è stata letta come un’adesione benjaminiana all’avanguardia tecnologica, obbedisce invece al metodo delle accelerazioni e dei rallentamenti temporali, che costituiscono il “tempo” della Recherche, il suo ritmo interno e segreto. L’immagine telescopica, attraverso cui Proust avvicinava le cose è esattamente la distruzione della lontananza che protegge gli oggetti e le immagini nel culto, teorizzata da Benjamin nell’Opera d’arte. Comune ad entrambi è anche l’impegno di decifrazione dei frammenti in cui si decompongono le immagini desacralizzate, per giungere attraverso la loro interpretazione, a costruire una diversa immagine del tempo, un diverso senso, che viene raggiunto proprio al prezzo di una profanazione, di un vero e proprio attraversamento dell’abisso infernale in cui le cose sembrano mostrarsi solo come mostruosa materialità».E in nota Rella cita il brano di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, VII: Il tempo ritrovato, trad. it. di G. Caproni, Einaudi, Torino 1978, p. 383, che noi invece traiamo dalla edizione Meridiani, vol. IV, trad. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano, p. 752 :«Anche chi fu favorevole alla mia percezione delle verità che intendevo poi incidere nel tempio si rallegrò che le avessi scoperte “al microscopio”, quando era invece di un telescopio che m’ero servito per scorgere cose piccolissime, è vero, ma per il fatto di essere situate a una grande distanza, e ciascuna delle quali era un mondo. Mi si chiamava collezionista di particolari, mentre erano le grandi leggi che cercavo».
Qualche tempo fa, attraverso la lettura di Franco Rella, Il silenzio e le parole, Feltrinelli, Milano 2001, ci è accaduto di ritrovare un brano del Tempo ritrovato di Marcel Proust, ivi ripreso con riferimento a Walter Benjamin e particolarmente interessante per la consonanza “metodologica” che per noi evoca. Ma teniamolo in serbo un poco, e seguiamo come recentemente vi siamo tornati con gran conforto.Pochi giorni fa, attraverso la lettura del saggio di James A. Boon, Perché i musei mi mettono tristezza, in Politiche e politiche dell’allestimento museale, a cura di Ivan Karp, Steven D. Lavine, introduzione di Fredi Drugman, Clueb, Bologna 1995, ci siamo imbattuti in un’altra (non necessariamente nel senso di una alternativa escludente) lettura di Proust, che segue la citazione (ivi, p. 154) di Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, pp. 145-146, ovvero 1995, p. 151, là dove parla delle illustrazioni di Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard) che, proprio nell’epoca delle esposizioni universali, rappresenta «oggetti morti» che «si depositano chiaramente nella spécialité – una qualifica o etichetta che sorge in questo periodo dell’industria di lusso; sotto la matita di Grandville la natura intera si trasforma in spécialités. Egli la presenta nello stesso spirito in cui la réclame – anche questa parola sorge in questo periodo – comincia a presentare i suoi articoli. Finisce pazzo».Ma non perdiamo di vista Proust – fra l’altro passeremo per Venezia.Scrive infatti Boon (ivi, pp. 155 ss): «Potete visitare L’Aia (deux étoiles), entrare nel museo Mauritshuis (trois étoiles) sedere con devozione davanti alla veduta di Delft di Vermeer e ascoltare i visitatori francesi recitare, come a memoria, non Proust su Vermeer ma la citazione nella Guida Michelin delle parole del Narratore della Recherche su Vermeer, che può essere la cosa giusta da recitare in questo genere di visite. Io stesso ho avuto modo di sentire più volte, intonata dai visitatori, questa appropriata didascalia, tratta da una guida non precisamente banale: “le plus beau tableau du monde”. Questo saccheggio di Proust da parte del Guide Miche è stato a sua volta saccheggiato dai visitatori, che recitano a voce alta il panegirico, senza preoccuparsi troppo dell’altro visitatore che, lì accanto, vorrebbe leggere in silenzio la Veduta di Vermeer […]. Ora, per quanto mi è stato possibile capire, origliando, questa attività non ha reso i passanti francesi a loro volta melanconici, e neppure allegri, peraltro. Ma chissà. Questi ritmi di riappropriazione resero comunque Proust, o il suo Narratore, triste, o melanconico, o incline alla musica o consapevole della necessità per la memoria di nutrirsi di strati di frammentarie leggende di residui del passato e di luoghi già frammentati e etichettati – come i musei. Proprio questo era la prosa di Proust, e dei suoi predecessori: saccheggio di saccheggio di saccheggio [ma, vorremmo aggiungere, con quale altezza e onestà!].Proust fece oggetto di saccheggio e di “pastiche” [in specie con Pastiches et mélanges] un gran numero di prosatori, compreso Ruskin, di cui addirittura tradusse Sesame and Lillies, scoprendo così una vocazione a scrivere secondo una memoria accumulativa che non si riduceva a una semplice rievocazione [per chiudere il cerchio si dovrebbe ricordare che Benjamin, per parte sua, tradusse Proust]. Tra le opere di Ruskin che Proust saccheggiò su suggerimento della madre c’erano le famose verbalizzazioni e visualizzazioni che suscitavano un vivo senso del luogo e del tempo con riferimento a quello che è forse il luogo più saccheggiato sulla terra: Venezia. […] La museificazione di Venezia a opera di Ruskin, da una parte, la salvò da un certo tipo di concezione turistica (quella che in precedenza l’aveva salvata) e, dall’altra, lanciò una nuova maniera e un nuovo stile di gustare-Venezia che nelle epoche successive l’avrebbe salvata più e più volte. E Venezia non è mai rimasta quel che era. E non si può neppure dire che la stessa Venezia (sposa del mare) non possa essere accusata di saccheggio e sfruttamento. La città cominciò a costituirsi in museo, o più precisamente in reliquiario, molti secoli prima che i viaggiatori e i voyeurs lettori di Ruskin insieme trasformassero Venezia in un composito emblema politico-estetico, con la speranza di redimere l’Europa industriale. […] Se mai una città era destinata a finir museificata – e in un certo senso tutte possono esserlo – quella fu proprio Venezia. Quando il Narratore di Proust descrive Venezia, lo fa sulla scia di una catalogazione che si vuole esaustiva come quella di Ruskin […]». E con riferimento ai ricordi involontari proustiani, scrive Boon (ivi, p. 159): «il narratore finisce col riconoscere nelle sue anticipazioni come nei suoi ricordi i mediatori dell’“esperienza”; più precisamente, ogni esperienza pura sarebbe tesa tra i poli irriducibili dell’anticipazione del ricordo, ed è proprio questa tensione che il narratore finisce col descrivere».Ora, di fronte a questo Proust saccheggiatore e accumulatore, abbiamo ripreso in mano il testo di Rella, Il silenzio e le parole, cit., p. 148, che ricorda le affinità quasi esistenziali fra Benjamin e Proust – «la malattia, il riso, il collezionismo: anche delle “reliquie della memoria”» – ma soprattutto come il primo assumesse nelle opere della maturità il modello teorico proustiano: «Nell’Opera d’arte nell’età della sua riproducibilità tecnica, la distruzione dell’aura, che è stata letta come un’adesione benjaminiana all’avanguardia tecnologica, obbedisce invece al metodo delle accelerazioni e dei rallentamenti temporali, che costituiscono il “tempo” della Recherche, il suo ritmo interno e segreto. L’immagine telescopica, attraverso cui Proust avvicinava le cose è esattamente la distruzione della lontananza che protegge gli oggetti e le immagini nel culto, teorizzata da Benjamin nell’Opera d’arte. Comune ad entrambi è anche l’impegno di decifrazione dei frammenti in cui si decompongono le immagini desacralizzate, per giungere attraverso la loro interpretazione, a costruire una diversa immagine del tempo, un diverso senso, che viene raggiunto proprio al prezzo di una profanazione, di un vero e proprio attraversamento dell’abisso infernale in cui le cose sembrano mostrarsi solo come mostruosa materialità».E in nota Rella cita il brano di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, VII: Il tempo ritrovato, trad. it. di G. Caproni, Einaudi, Torino 1978, p. 383, che noi invece traiamo dalla edizione Meridiani, vol. IV, trad. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano, p. 752 :«Anche chi fu favorevole alla mia percezione delle verità che intendevo poi incidere nel tempio si rallegrò che le avessi scoperte “al microscopio”, quando era invece di un telescopio che m’ero servito per scorgere cose piccolissime, è vero, ma per il fatto di essere situate a una grande distanza, e ciascuna delle quali era un mondo. Mi si chiamava collezionista di particolari, mentre erano le grandi leggi che cercavo».
Design 1999: il museo
 Non trovando traccia scritta di una delle Lezioni di design condotte da Ugo Gregoretti – programma Rai, autori Stefano Casciani e Anna Del Gatto, regia Maurizio Malabruzzi – dedicata al tema del Museo del design italiano e di cui rimane invece traccia video negli archivi Rai, ci siam presi la briga di darne trascrizione fedele. Ricavando da questo viaggio nel tempo non poche informazioni e interessanti suggestioni: speranze e disillusioni già provate dai fatti.[intro]Andrea Branzi: “I musei esistono se c’è un curatore, un direttore capace di farli vivere, altrimenti sono delle collezioni che non servono a nessuno.”Giulio Castelli: “Penso che questo museo debba essere il posto, il locale, il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica.”Makio Hasuike: “Non saprei se è tutto negativo la non esistenza di un museo.”Luca Scacchetti: “Non è un dramma che non esista un museo del design, va benissimo andarsi a cercare gli esempi storici su “Casabella” degli anni sessanta; non è importantissimo. È segno di un disastro.”Vittorio Fagone: “Credo che un museo del design in Italia andrebbe fatto.”Hasuike: “Veramente io non so dove mandare i miei amici per vedere le cose di design, non esiste.”Fagone: “Questo museo del design è praticamente forse fatto nelle case di molti italiani.”Castelli: “Il primo museo che ho visto di design naturalmente è stato il MoMA a New York.”Hasuike: “Ho visto il museo di Londra del design, però mi pare che già quello che è stato fatto alla Triennale qualche anno fa è nettamente superiore, a mio modo di vedere.”Branzi: “Oggi indubbiamente credo il museo del design fatto in maniera intelligente sarebbe importante averlo.”Castelli: “Bisogna fare un museo che sia vivo, che sia in movimento; un museo fermo e statico dove la gente passa e guarda i prodotti – specialmente di disegno industriale – mi sembra una cosa ormai superata.”Fagone: “Il museo del design italiano è nella vita di tutti noi, per fortuna.”Ugo Gregoretti: «In Italia, culla del design contemporaneo, non esiste un museo nazionale, centrale, pubblico del design, così come non esiste una sezione del design in alcun museo pubblico italiano di arte contemporanea. I musei di attrezzi agricoli, le raccolte di contadinerie ormai non si contano, pullulano in tutta la penisola; del design, scarse tracce. Mi si è detto che poiché la civiltà contadina è estinta è giusto custodirne le memorie prima che scompaiano. Certo. Ma allora dobbiamo aspettare che si estingua la civiltà urbana, metropolitana, industriale, postindustriale, telematica, futurologica per avere finalmente tra qualche millennio il museo italiano del design. Ma, ci si può obiettare, l’Italia è come risaputo un museo all’aria aperta, lo dicono tutti, e quindi godiamoci all’aria aperta le sedie e i tavolini del caffé, le caffettiere e le lampade, le carrozzerie delle automobili, gli oggetti eleganti esposti nelle vetrine dei negozi, i negozi stessi, disegnati dai nostri eccellenti designer. Che bisogno c’è di metterli ad ammuffire in un museo?»[sigla]UG: «Cominciamo con Paola Antonelli del MoMA di New York. Esiste un rapporto antico tra il suo museo e il design italiano…»Paola Antonelli: «Esiste un rapporto antico tra il museo e il design, antico quanto il museo, perché quando il museo è stato fondato nel 1929 il primo direttore del museo che aveva 27-28 anni a quel tempo, Alfred Barr era il suo nome, era quello che aveva deciso che tra le forme di arte moderna ci dovessero essere la fotografia e il cinema, il design e l’architettura. Il curatore a quel tempo era Philip Johnson – che adesso ha 92 anni ed è ancora pimpante, ancora dice la sua – e fin dall’inizio del museo il design ha fatto parte del catalogo dei capolavori di arte contemporanea mondiali.»UG: «Ci fu una famosa mostra nel 1930…»PA: «Beh quella è una mostra di architettura sull’International style, sull’archiettura modernista internazionale; ma il design italiano ha cominciato a entrare nel museo quando ha cominciato a sbocciare nel mondo. Perché, diciamo, negli anni trenta-quaranta il design italiano era talmente sottile… ci voleva tempo per capirlo, non era ancora veramente protagonista. Negli anni cinquanta e soprattutto con gli anni sessanta la collezione ha cominciato a ingrassarsi di design italiano, finché c’è stata una grande mostra nel 1972 che da molti storici qui presenti è considerata quasi un “canto del cigno” di una certa parte del design italiano, si chiamava Italy. The new domestic landscape, era stata organizzata da un curatore argentino Emilio Ambasz ed era una mostra splendida, in cui c’era tutto il meglio del design italiano degli anni sessanta e dell’inizio settanta.»UG: «E il MoMA ha accolto altri prototipi del design italiano, dopo?»PA: «Sì… usando la parola prototipi, abbiamo molto pochi prototipi, sono quasi tutti pezzi di produzione; ma continuamente, ogni volta che c’è un bel pezzo di design italiano o prodotto in Italia viene considerato per la collezione, quindi anche adesso, sì.»UG: «Quindi c’è speranza anche per i designer delle nuove generazioni di approdare prima o poi al MoMA?»PA: «Scherziamo? Certo! Continuamente.»UG: «Bene, grazie. Il signor Alexander van Vegesack, del Vitra Museum… lei è un collezionista che ha fatto della sua collezione il nucleo, il perno di una raccolta che poi si è sviluppata, si è arricchita…»Alexander van Vegesack: «Ho cominciato molto presto a collezionare mobili, ma all’inizio mi sono particolarmente concentrato a organizzare tutto quello che era la produzione di serie. Subito dopo mi sono immediatamente impegnato in tutte le altre fasi del processo della produzione di mobili: plastica, fibre di vetro e tutte quelle tecniche che noi oggi conosciamo. Quando la collezione ha cominciato a prendere forma io mi sono dato da fare per organizzare le prime mostre, mentre allo stesso tempo cercavo di condurre ricerche sulle fasi del processo produttivo e sul design stesso.»UG: «Lei è anche direttore del museo?»AvV: «Sì, è stata una mia idea fondare il museo e sono quindi responsabile del programma e dell’organizzazione intera del museo.»UG: «La signora Cathy Leff, direttrice del Wolfsonian – ho detto più o meno… così e così… – Museum di Miami, con una attenzione, mi pare di avere capito, particolare alla produzione italiana.»Cathy Leff: «La fondazione Wolfsonian è stata fondata da Mitchell Wolfson Jr.»UG: «… magnate diciamo così…»CL: «… è molto interessante perché ha trascorso parte della sua vita in Italia, sviluppando la carriera diplomatica. Ha cominciato con dei semplicissimi materiali, ha cominciato con gli inizi della produzione industriale e la nostra collezione raggiunge ora il 1945, quindi una parte molto significativa di questa collezione ha una origine italiana.»UG: «Benissimo, grazie. Adesso il primo ospite cosiddetto “su nastro”, l’achitetto e designer Luca Scacchetti.»Luca Scacchetti [testimonianza video]: «Maniacale… mi piacerebbe molto che il museo del design avesse un aspetto maniacale… che riuscisse – non so con quali sistemi, ma l’informatica in questo aiuta molto – proprio a contenere tutto il design fatto, non solo quello di adesso. C’è un bellissimo racconto su un cartografo, di Borges, e racconta come questo cartografo facesse questa carta della Spagna ma sempre a una scala maggiore, ma sempre insoddisfatto dell’imprecisione a contenere tutte le notizie che in realtà in Spagna ci sono. Fin quando alla fine della sua vita riuscirà a disegnare una carta che sovrapponendola alla Spagna corrispondeva esattamente. Cioè aveva disegnato una carta che era grande quanto la Spagna. Così mi piacerebbe che fosse il museo del design.»UG: «Giovanni Pinna, presidente del comitato italiano dell’International Council of Museums. I musei internazionali accolgono, pare di capire, maggiormente la cosiddetta “cultura materiale” e il design rispetto a quelli italiani. È così?»Giovanni Pinna: «Sì questo è abbastanza evidente. Probabilmente deriva dal fatto che gli italiani non sanno riconoscere il valore di quello che fanno. In realtà la comunità deve spingere per la creazione dei musei; i musei si creano di solito dal basso per interesse della società o di elementi della società che collezionano oggetti che testimoniano la loro storia, la loro origine, la loro cultura… Qui quello che sembra è che non ci sia questa spinta a costruire… e questa è una cosa strana per una città come Milano che ha una vocazione in questo campo, e sembra che non riconosca queste sue vocazioni.»UG: «Eh questo sembra un argomento delicato… Comunque vediamo che cosa succede a Milano.»[immagini della mostra Museo del Design – Collezione Permanente del design italiano 1945-1990 della Triennale di Milano]UG: «Ecco oggi questo che era, che è stato per un breve tempo il museo del design della Triennale di Milano non sta più alla Triennale. Non è scomparso, non è che si siano polverizzati questi reperti. Sono stati traslocati e non più, perlomeno, non tanto facilmente accessibili al visitatore medio; se tra i visitatori medi possiamo includerci anche noi come inviati della televisione, in realtà non ci è stato consentito, non è stato consentito al regista con i suoi operatori di filmare questi oggetti, questi mobili, che oggi si trovano al Politecnico. Ecco ora sentiamo l’architetto Giampiero Bosoni, responsabile scientifico della collezione permanente del museo del design della Triennale di Milano. Ecco, ci parli un po’ di queste tormentate vicende e anche del destino futuro della Triennale e della sua collezione.»Giampiero Bosoni: «Sono contento che si siano accennati, nei passaggi anche precedenti, come per esempio nell’intervento di Makio Hasuike – il designer che ha parlato all’inizio della trasmissione – e anche di Andrea Branzi, al fatto che questa collezione esiste e ha potenzialmente delle grandi caratteristiche che a Milano mancano, per quanto ne parlavamo prima con il nostro punto di riferimento, faro storico della critica e della storia del disegno industriale, Gillo Dorfles, da più di quarant’anni, quasi cinquanta, da quando Adriano Olivetti si è fatto portavoce, grande sostenitore della cultura del design italiano, occorresse pensare a un luogo dove poter portare in esposizione, mantenere la cultura storica del design italiano. Mi fa piacere che Makio Hasuike abbia accennato che poi oggi quella collezione storica che la Triennale ha potuto tenere in esposizione per un anno e mezzo – tutto sommato la più lunga esposizione che la Triennale abbia avuto dal 1933 a oggi, quindi è stato comunque un importante contributo – sia rispetto a quella londinese, per esempio secondo Hasuike, comunque un grande patrimonio. Io vi posso parlare molto bene della storia, di come è nata questa collezione, e dirvi quello che a me risulta del suo futuro, perché sicuramente ne ha di futuro. Vorrei dirvi che questa collezione è molto ben esposta, o comunque correttamente esposta su 1600 mq presso la sede, nella sede, potremmo dire, della facoltà nuova di disegno industriale del Politecnico di Milano; e questo fatto, almeno di principio, lo trovo molto buono. Purtroppo è poco visitabile, mi dispiace molto che non lo sia stato per il regista di questa trasmissione. Sta di fatto che quella collezione, che rimane un contributo importante di livello internazionale, esiste e sta crescendo, perché da come era stata tenuta in esposizione presso la Triennale oggi dispone anche di un preziosissimo, nuovo contributo che è la famosa collezione dei modelli storici di Giovanni Sacchi che con accordi avvenuti recentemente è stata in effetti comperata dalla Regione di Milano [sic] e data in deposito – come ulteriore contributo storico – alla collezione storica della Triennale.»UG: «Quindi è importante che Milano si dia questo museo.»GB: «Io direi che c’è una cosa di cui parlavamo, e io ho scritto di questo anche sulle riviste di settore, visto che sono stato uno di quelli che ha forzato certe resistenze perché comunque si potesse portare in esposizione questo patrimonio storico. Dire che questa a oggi in questo momento è una grande potenzialità, è vero quello che dice Branzi che un museo non è solo una collezione, ma io credo per un museo occorre una collezione, che comunque è un elemento forte e importante di questo grande organismo che indubbiamente la Triennale sola non poteva e non è riuscita a sostenere.»UG: «Comunque datevi da fare perché alcuni segni fanno intendere che Roma “ladrona” sia in agguato. È vero Anna Del Gatto, autrice e curatrice del programma che introduce ora l’agguato romano…»Anna Del Gatto: «Sì, Ugo, senti io vorrei interrompere un momento per dire che nel pubblico è arrivato ora Giovanni Sacchi, che era stato citato adesso da Bosoni e quindi volevo fargli un omaggio perché è una persona grande per tutti noi…»[applauso]Giovanni Sacchi: «Potrei dire che sono il museo del design. Io son nato costruendo modelli per fonderie. Poi l’incontro causale [sic] con Nizzoli negli anni cinquanta mi ha portato a trasformarmi nel designer. Posso dire che da me sono passati tutti i designer italiani, specialmente i milanesi – vedo delle facce note che hanno studiato con Nizzoli. Abbiamo creato tanti modelli, abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo disperso un patrimonio di lavoro… perché? Non c’è mai stata una raccolta di questo. Cinquant’anni che predico questo museo… non un museo perché è un museo… Nel conservare questo fattore di lavoro che hanno fatto questi designer italiani, che hanno sviluppato nel mondo intiero la loro intelligenza… non si può nascondere: la moda ha fatto il suo passo, ma il design ha fatto di più della moda, perché l’industria italiana con il designer si è evoluta in tutti i campi e fa fede ancora oggi il nostro designer. Vediamo ancora i nostri designer richiesti. Guardate che oggi da me c’erano 40 finlandesi. Perché vengono da me? Perché manca l’incontro scuola e lavoro… Domani io vado in Svizzera, perché mi hanno invitato; e perché questo invito come persona unica? Perché il design italiano è stato lì, messo da parte, non lo abbiamo mai sviluppato per quello che era, per quello che è. E tuttora il designer italiano è alla testa del lavoro italiano. Non c’è un prodotto che non sia disegnato da un designer italiano. E questa è una evoluzione che bisogna conservarla, anche con il museo, partendo naturalmente dai prototipi, dallo studio del lavoro che fa il designer… non è che disegna perfettamente e basta: il designer costruisce man mano che il lavoro nasce; il modello nasce in base all’idea del designer.»UG: «Bene, sentiamo Sandra Pinto, direttrice della Galleria nazionale di arte moderna di Valle Giulia a Roma.»Sandra Pinto [testimonianza video]: «Il progetto vincitore è un progetto che ha perfettamente inteso lo spirito; è un progetto di ingegneria istituzionale altrettanto difficile quanto il tema architettonico. Si tratta infatti adesso di passare da un’idea generale a un’idea di dettaglio e molto precisata su un qualcosa che non è un museo e non è una università ma è un grande centro di produzione della cultura contemporanea, in cui il momento della creazione, il momento dell’informazione, il momento dello scambio interattivo tra l’arte, la società e la cultura si cristallizza il minuto successivo in una forma di memoria e di museo. Certamente è importante che ci si possa confrontare su tutto poi il vasto patrimonio di fatti che interessano la cultura contemporanea. Il centro lo farà con un polo importante per la ricerca e anche per la ricerca avanzata, come pure con gli strumenti da portare a immediata disposizione del pubblico. Sia il progetto architettonico sia il progetto istituzionale lavora su un concetto di navigazione, come se fossimo in una sorta di internet ma in uno spazio reale non in uno spazio virtuale. Le domande da porsi interrelatamente fra una forma artistica e l’altra, fra una disciplina e l’altra, fra un medium e l’altro dovrebbero avvenire nello spazio grande ma non grandissimo di 27.000 mq.»UG: «Il professor Gillo Dorfles, diciamo l’ornamento maggiore di questo incontro di oggi…»Gillo Dorfles: «Non esageriamo, non esageriamo soprattutto…»UG: «No, no, come non esageriamo… Penso siamo tutti d’accordo. Questo mito del design milanese ha ragione di continuare, come dire, nel suo rigoglio?»GD: «Sì per una volta una fama non è usurpata. Bisogna riconoscere che Milano ha avuto la straordinaria fortuna, più che abilità, di inventare il design quando ancora in Italia non si sapeva che cosa fosse. In un certo senso Milano ha fatto il design e solo dopo cinque o sei anni si è accorta che si trattava di design. Molti industriali milanesi avevano degli studi, ricorrevano a professionisti, soprattutto architetti, e non sapevano neanche che la parola “design” volesse dire quello che oggi sappiamo voglia dire. Difatti per molto tempo si è discusso: bisogna dire “disegno industriale” o bisogna dire “design”? Ma a parte questo, non c’è dubbio che Milano da cinquant’anni a questa parte è la capitale del design, è quella che ha dato maggiore apporto, maggiori scoperte formali in questo campo. E difatti anche all’estero quasi tutti riconoscono a Milano questa caratteristica.»UG: «Qual è la peculiarità naturale che consente al design milanese di essere così universale?»GD: «Io credo che è dovuta all’incontro di una sufficiente attenzione alla funzione, alla funzionalità degli oggetti, come del resto anche i giapponesi, gli americani, i tedeschi sanno fare, e una inventiva che è particolare del designer italiano. Quindi questo incontro delle due cose, che a volte ha dato origine anche a degli scontri sanguinosi, ha fatto sì che sono venuti alla luce degli oggetti del tutto particolare che non avrebbero mai potuto avere natali in Germania, o America e neppure in Inghilterra.»UG: «Quindi il design milanese affonda le radici nella grande tradizione italiana…»GD: «… in fondo gli italiani di oggi, che non sono più i grandi pittori del Rinascimento, che non sono più i grandi architetti barocchi, che non sono più i grandi artisti di un millennio, nel campo del design hanno ritrovato le radici che pareva avessero perduto.»UG: «E quindi questo museo del design?»GD: «Eh, qui il problema, perché bisogna intendersi prima di tutto su che cosa è o dovrebbe essere il museo del design. Perché non basta mettere un migliaio di oggetti uno accanto all’altro – cosa che per conto mio è sbagliata – bisogna trovare il modo che il museo del design abbia i prototipi fondamentali ma abbia anche i progetti, abbia anche i disegni esecutivi, abbia anche tutto quell’insieme di materia preparatoria al design che è fondamentale. Per questo prima di dire “museo di design” bisognerebbe decidere come sarà o sarebbe questo design: come il Victoria&Albert Museum o come la raccolta archivio di Quintavalle a Parma? Sono due poli che possono confluire in un museo del design.»UG: «O come il museo di Groningen in Olanda, del quale ora vedremo le immagini e poi così a sorpresa vi diremo chi è e dove sta l’autore.»[immagini del museo di Groningen]UG: «L’autore di questo mitico museo del quale abbiamo assaporato una specie di videoclip è qui seduto accanto a me ed è l’architetto Alessandro Mendini, diciamo, la cui fama è talmente vasta e salda, che è superfluo che io la riconfermi. Ecco, architetto, come è stata l’esperienza della costruzione di questo museo? Lei ha avuto anzitutto un committente nella persona del suo direttore, il soprintendente, il signore [Frans] Haks, con il quale ha in qualche modo concertato l’impostazione…»Alessandro Mendini: «Sì esatto. L’avventura bellissima – il museo adesso ha cinque anni – è cominciata quando questo signor Haks ha suonato il campanello del mio studio e mi ha chiesto di progettargli il museo della città di Groningen, che è un museo che va dalla archeologia a una pinacoteca, a dei padiglioni fino all’arte contemporanea. Appunto perché diviso in padiglioni specializzati è una specie di somma di piccoli musei che danno luogo a un macromuseo, a una sintesi. Sulla base di questa situazione anche proprio urbanistica abbiamo deciso di invitare alcuni architetti ospiti, per cui l’architettura è una somma di architetture contemporanee di diversa caratteristica linguistica e pertanto lo stesso museo si presenta in maniera “automuseale”… come potrei dire…»UG: «Lei è stato l’architetto padre…»AM: «Sono il coordinatore generale di tutta questa cosa complessa.»UG: «… che ha ricostituito intorno a questa impresa quello che ‘è il suo habitat naturale di lavoro, che è l’atelier.»AM: «Sì, io sono abituato e mi interessa anche molto lavorare con persone diverse, nel senso che abbiano la testa anche molto diversa dalla mia, e pertanto i miei lavori in genere sono dei patchwork…»UG: «… però lei ha detto “purché imparino l’alfabeto” cioè l’alfabeto di Mendini…»AM: «Beh sì, c’è di mezzo evidentemente una specie di necessità di sintesi per arrivare a un obiettivo che rimane però sempre un po’ aperto perché non si ha mai l’ultima parola nel momento in cui lavorano creativamente anche gli altri.»UG: «Ed è stato edificato su un’isola artificiale al centro di un canale altrettanto artificiale.»AM: «Sì, come succede in Olanda, questo museo è nell’acqua, è un’isola fra due ponti dei quali uno levatoio perché tanto passano le navi; si stanno progettando probabilmente anche dei padiglioni a zattera che possono arrivare anche magari a Amsterdam o più lontano…»UG: «Le piacerebbe costruire il museo del design di Milano?»AM: «No. Io mi sono occupato del museo… di musei di design a Milano, penso, per trent’anni: ogni anno ne saltava fuori uno; ho cominciato con Gio Ponti e con Roberto Olivetti, e con Dorfles anche, e progressivamente mi sono assolutamente defaticato e non mi interessa sentire parlare di museo di design a Milano.»UG: «Mentre invece altrove sì?»AM: «Dove c’è qualche speranza, perché qui la speranza, secondo me, nonostante quello che dice Bosoni non c’è.»UG: «Ho capito. Sentiamo adesso un’altra rapida testimonianza di un ospite “riprodotto”, Vittorio Fagone, critico d’arte e direttore della galleria, della Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo.»Vittorio Fagone [testimonianza video]: «Quando nel 1995 ho potuto dedicare una mostra a Gianni e Joe Colombo, lo sconcerto di alcuni visitatori che, abituati a visitare uno spazio museale vi trovavano esposti degli oggetti, e qualcuno diceva “Mah, il museo è diventato la Rinascente”, questo dato di contemporaneità, a mio giudizio, contemporaneità in cui si trovano il fruitore e il progettista, è il dato più affascinante dell’universo del design.»UG: «Stefano Casciani, giornalista, esperto di design e architetto coautore del nostro programma. Come mai gli architetti italiani costruiscono musei all’estero e i nostri musei vengono progettati dagli stranieri, per esempio l’architetta [sic] Aziz [sic] [2xsic=sigh] che ha vinto il concorso per il nuovo centro di arte contemporanea romano.»Stefano Casciani: «Questa che tu sollevi è una polemica ormai di livello internazionale. Ho scovato l’altro giorno su internet una notizia deliziosa a proposito delle polemiche che stanno sorgendo negli stati uniti a Chicago perché Renzo Piano ha vinto un concorso internazionale per l’estensione dell’Art Institute di Chicago, che è uno dei musei più belli degli Stati Uniti. Negli stessi giorni iniziava anche a serpeggiare una polemica anche piuttosto pesante fatta da alcuni baroni dell’architettura italiana contro Zaha Hadid che ha avuto il coraggio di vincere il concorso per il centro internazionale delle arti contemporanee di Roma. Io credo che di fronte al fenomeno della globalizzazione tutte queste polemiche siano piuttosto ridicole e vogliano soltanto cercare di mantenere un impossibile equilibrio geografico culturale. Quindi mi sembra che il problema del museo ritorni comunque sulla centralità del problema dell’oggetto. Studiando questo problema per questa mostra con la galleria nazionale delle arti moderne di Roma, il dato interessante è proprio quello del ritorno del pubblico all’interesse verso l’oggetto. Paola Antonelli ha organizzato per il Museum of Modern Art di New York una mostra di Achille Castiglioni che ha avuto 100mila visitatori. Con Alessandro Mendini abbiamo realizzato una mostra al Louisiana Museum di Copenaghen sul design italiano e sul design europeo che ha avuto 106mila visitatori in tre mesi. Questi mi sembrano dati comunque positivi e interessanti, è forse su questo che ci dobbiamo concentrare per capire l’attualità e centralità dello specifico degli oggetti nei musei.»UG: «Franco Origoni, graphic designer, anche lei è d’accordo sulla necessità che si istituisca un msueo del design.»Franco Origoni: «Per fare il museo del design secondo me bisogna ricordarsi di un pezzettino che c’è in Nuovo cinema Paradiso di Tornatore, dove al ragazzo che ha nostalgia della Sicilia gli si dice “non ti voltare mai e vai avanti”. Cioè se vogliamo fare un museo del design in Italia è chiaro dobbiamo dimenticarci delle logiche che si intrecciano e che hanno impedito al museo di vivere. Ci sono le collezioni di design ormai diffuse; se citiamo oltre alle collezioni particolari dell’Alessi, c’è l’Alfa Romeo, c’è la Fiat, c’è la Caproni, ci sono una quantità di aziende che prima che fosse fatta la legge e dopo hanno messo insieme le loro collezioni… per cui quello che manca è un motore che ragioni sulla natura del design, sul ruolo del design e su che cosa è il design oggi. Non è un luogo fisico, il luogo fisico c’è e se ne trova… c’è una collezione straordinaria che va rivalutata.»UG: «E le cause che fino a oggi hanno impedito la realizzazione di questo…»FO: «Beh la concezione innanzi tutto del museo ottocentesco. Non voglio fare adesso una disquisizione filosofica su questa cosa però se si pensa che i musei di design sono una sequenza di oggetti esposti in maniera stabile in una teca fantastica, illuminati con una illuminazione bellissima, questo è un museo che è morto già dall’inizio. Il museo è un pezzo di serie, e non è comunque anche quando è un segno molto forte un pezzo unico come può essere un Piero della Francesca. Il rapporto nei musei d’arte – credo che Paola Antonelli ne sappia più di me – fra la parte di collezione e la parte esposta in maniera permanente si calcola nella progettazione dei musei nel rapporto di uno a cinque, cioè se ci sono mille metri quadri di esposizione ce ne sono cinquemila di organizzazione per fare funzionare il museo. Ci sono equipe che fanno funzionare il museo, che fanno ruotare le mostre sulla stessa collezione… Forse a questo bisognerebbe pensare, non alle polemiche che inseguiamo tutti i giorni.»UG: «Bene. Chiudiamo con un’ultima testimonianza registrata. Giulio Castelli, imprenditore: il museo del design che vorrebbe.»Giulio Castelli: «È molto più interessante avere un museo virtuale. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia del design, di un designer, e dei disegni tecnici di questo prodotto, e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti per poterlo guardare realmente. Ecco questo sarebbe secondo me l’ideale. Forse con i mezzi futuri, visto che si fanno i magazzini che schiacciando i bottoni si fanno le spedizioni, perché non si deve poter avere un magazzino dove schiacciando un bottone ci sia un nastro, un tapis roulant che porti questo pezzo davanti allo studente o al ricercatore o allo studioso.»
Non trovando traccia scritta di una delle Lezioni di design condotte da Ugo Gregoretti – programma Rai, autori Stefano Casciani e Anna Del Gatto, regia Maurizio Malabruzzi – dedicata al tema del Museo del design italiano e di cui rimane invece traccia video negli archivi Rai, ci siam presi la briga di darne trascrizione fedele. Ricavando da questo viaggio nel tempo non poche informazioni e interessanti suggestioni: speranze e disillusioni già provate dai fatti.[intro]Andrea Branzi: “I musei esistono se c’è un curatore, un direttore capace di farli vivere, altrimenti sono delle collezioni che non servono a nessuno.”Giulio Castelli: “Penso che questo museo debba essere il posto, il locale, il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica.”Makio Hasuike: “Non saprei se è tutto negativo la non esistenza di un museo.”Luca Scacchetti: “Non è un dramma che non esista un museo del design, va benissimo andarsi a cercare gli esempi storici su “Casabella” degli anni sessanta; non è importantissimo. È segno di un disastro.”Vittorio Fagone: “Credo che un museo del design in Italia andrebbe fatto.”Hasuike: “Veramente io non so dove mandare i miei amici per vedere le cose di design, non esiste.”Fagone: “Questo museo del design è praticamente forse fatto nelle case di molti italiani.”Castelli: “Il primo museo che ho visto di design naturalmente è stato il MoMA a New York.”Hasuike: “Ho visto il museo di Londra del design, però mi pare che già quello che è stato fatto alla Triennale qualche anno fa è nettamente superiore, a mio modo di vedere.”Branzi: “Oggi indubbiamente credo il museo del design fatto in maniera intelligente sarebbe importante averlo.”Castelli: “Bisogna fare un museo che sia vivo, che sia in movimento; un museo fermo e statico dove la gente passa e guarda i prodotti – specialmente di disegno industriale – mi sembra una cosa ormai superata.”Fagone: “Il museo del design italiano è nella vita di tutti noi, per fortuna.”Ugo Gregoretti: «In Italia, culla del design contemporaneo, non esiste un museo nazionale, centrale, pubblico del design, così come non esiste una sezione del design in alcun museo pubblico italiano di arte contemporanea. I musei di attrezzi agricoli, le raccolte di contadinerie ormai non si contano, pullulano in tutta la penisola; del design, scarse tracce. Mi si è detto che poiché la civiltà contadina è estinta è giusto custodirne le memorie prima che scompaiano. Certo. Ma allora dobbiamo aspettare che si estingua la civiltà urbana, metropolitana, industriale, postindustriale, telematica, futurologica per avere finalmente tra qualche millennio il museo italiano del design. Ma, ci si può obiettare, l’Italia è come risaputo un museo all’aria aperta, lo dicono tutti, e quindi godiamoci all’aria aperta le sedie e i tavolini del caffé, le caffettiere e le lampade, le carrozzerie delle automobili, gli oggetti eleganti esposti nelle vetrine dei negozi, i negozi stessi, disegnati dai nostri eccellenti designer. Che bisogno c’è di metterli ad ammuffire in un museo?»[sigla]UG: «Cominciamo con Paola Antonelli del MoMA di New York. Esiste un rapporto antico tra il suo museo e il design italiano…»Paola Antonelli: «Esiste un rapporto antico tra il museo e il design, antico quanto il museo, perché quando il museo è stato fondato nel 1929 il primo direttore del museo che aveva 27-28 anni a quel tempo, Alfred Barr era il suo nome, era quello che aveva deciso che tra le forme di arte moderna ci dovessero essere la fotografia e il cinema, il design e l’architettura. Il curatore a quel tempo era Philip Johnson – che adesso ha 92 anni ed è ancora pimpante, ancora dice la sua – e fin dall’inizio del museo il design ha fatto parte del catalogo dei capolavori di arte contemporanea mondiali.»UG: «Ci fu una famosa mostra nel 1930…»PA: «Beh quella è una mostra di architettura sull’International style, sull’archiettura modernista internazionale; ma il design italiano ha cominciato a entrare nel museo quando ha cominciato a sbocciare nel mondo. Perché, diciamo, negli anni trenta-quaranta il design italiano era talmente sottile… ci voleva tempo per capirlo, non era ancora veramente protagonista. Negli anni cinquanta e soprattutto con gli anni sessanta la collezione ha cominciato a ingrassarsi di design italiano, finché c’è stata una grande mostra nel 1972 che da molti storici qui presenti è considerata quasi un “canto del cigno” di una certa parte del design italiano, si chiamava Italy. The new domestic landscape, era stata organizzata da un curatore argentino Emilio Ambasz ed era una mostra splendida, in cui c’era tutto il meglio del design italiano degli anni sessanta e dell’inizio settanta.»UG: «E il MoMA ha accolto altri prototipi del design italiano, dopo?»PA: «Sì… usando la parola prototipi, abbiamo molto pochi prototipi, sono quasi tutti pezzi di produzione; ma continuamente, ogni volta che c’è un bel pezzo di design italiano o prodotto in Italia viene considerato per la collezione, quindi anche adesso, sì.»UG: «Quindi c’è speranza anche per i designer delle nuove generazioni di approdare prima o poi al MoMA?»PA: «Scherziamo? Certo! Continuamente.»UG: «Bene, grazie. Il signor Alexander van Vegesack, del Vitra Museum… lei è un collezionista che ha fatto della sua collezione il nucleo, il perno di una raccolta che poi si è sviluppata, si è arricchita…»Alexander van Vegesack: «Ho cominciato molto presto a collezionare mobili, ma all’inizio mi sono particolarmente concentrato a organizzare tutto quello che era la produzione di serie. Subito dopo mi sono immediatamente impegnato in tutte le altre fasi del processo della produzione di mobili: plastica, fibre di vetro e tutte quelle tecniche che noi oggi conosciamo. Quando la collezione ha cominciato a prendere forma io mi sono dato da fare per organizzare le prime mostre, mentre allo stesso tempo cercavo di condurre ricerche sulle fasi del processo produttivo e sul design stesso.»UG: «Lei è anche direttore del museo?»AvV: «Sì, è stata una mia idea fondare il museo e sono quindi responsabile del programma e dell’organizzazione intera del museo.»UG: «La signora Cathy Leff, direttrice del Wolfsonian – ho detto più o meno… così e così… – Museum di Miami, con una attenzione, mi pare di avere capito, particolare alla produzione italiana.»Cathy Leff: «La fondazione Wolfsonian è stata fondata da Mitchell Wolfson Jr.»UG: «… magnate diciamo così…»CL: «… è molto interessante perché ha trascorso parte della sua vita in Italia, sviluppando la carriera diplomatica. Ha cominciato con dei semplicissimi materiali, ha cominciato con gli inizi della produzione industriale e la nostra collezione raggiunge ora il 1945, quindi una parte molto significativa di questa collezione ha una origine italiana.»UG: «Benissimo, grazie. Adesso il primo ospite cosiddetto “su nastro”, l’achitetto e designer Luca Scacchetti.»Luca Scacchetti [testimonianza video]: «Maniacale… mi piacerebbe molto che il museo del design avesse un aspetto maniacale… che riuscisse – non so con quali sistemi, ma l’informatica in questo aiuta molto – proprio a contenere tutto il design fatto, non solo quello di adesso. C’è un bellissimo racconto su un cartografo, di Borges, e racconta come questo cartografo facesse questa carta della Spagna ma sempre a una scala maggiore, ma sempre insoddisfatto dell’imprecisione a contenere tutte le notizie che in realtà in Spagna ci sono. Fin quando alla fine della sua vita riuscirà a disegnare una carta che sovrapponendola alla Spagna corrispondeva esattamente. Cioè aveva disegnato una carta che era grande quanto la Spagna. Così mi piacerebbe che fosse il museo del design.»UG: «Giovanni Pinna, presidente del comitato italiano dell’International Council of Museums. I musei internazionali accolgono, pare di capire, maggiormente la cosiddetta “cultura materiale” e il design rispetto a quelli italiani. È così?»Giovanni Pinna: «Sì questo è abbastanza evidente. Probabilmente deriva dal fatto che gli italiani non sanno riconoscere il valore di quello che fanno. In realtà la comunità deve spingere per la creazione dei musei; i musei si creano di solito dal basso per interesse della società o di elementi della società che collezionano oggetti che testimoniano la loro storia, la loro origine, la loro cultura… Qui quello che sembra è che non ci sia questa spinta a costruire… e questa è una cosa strana per una città come Milano che ha una vocazione in questo campo, e sembra che non riconosca queste sue vocazioni.»UG: «Eh questo sembra un argomento delicato… Comunque vediamo che cosa succede a Milano.»[immagini della mostra Museo del Design – Collezione Permanente del design italiano 1945-1990 della Triennale di Milano]UG: «Ecco oggi questo che era, che è stato per un breve tempo il museo del design della Triennale di Milano non sta più alla Triennale. Non è scomparso, non è che si siano polverizzati questi reperti. Sono stati traslocati e non più, perlomeno, non tanto facilmente accessibili al visitatore medio; se tra i visitatori medi possiamo includerci anche noi come inviati della televisione, in realtà non ci è stato consentito, non è stato consentito al regista con i suoi operatori di filmare questi oggetti, questi mobili, che oggi si trovano al Politecnico. Ecco ora sentiamo l’architetto Giampiero Bosoni, responsabile scientifico della collezione permanente del museo del design della Triennale di Milano. Ecco, ci parli un po’ di queste tormentate vicende e anche del destino futuro della Triennale e della sua collezione.»Giampiero Bosoni: «Sono contento che si siano accennati, nei passaggi anche precedenti, come per esempio nell’intervento di Makio Hasuike – il designer che ha parlato all’inizio della trasmissione – e anche di Andrea Branzi, al fatto che questa collezione esiste e ha potenzialmente delle grandi caratteristiche che a Milano mancano, per quanto ne parlavamo prima con il nostro punto di riferimento, faro storico della critica e della storia del disegno industriale, Gillo Dorfles, da più di quarant’anni, quasi cinquanta, da quando Adriano Olivetti si è fatto portavoce, grande sostenitore della cultura del design italiano, occorresse pensare a un luogo dove poter portare in esposizione, mantenere la cultura storica del design italiano. Mi fa piacere che Makio Hasuike abbia accennato che poi oggi quella collezione storica che la Triennale ha potuto tenere in esposizione per un anno e mezzo – tutto sommato la più lunga esposizione che la Triennale abbia avuto dal 1933 a oggi, quindi è stato comunque un importante contributo – sia rispetto a quella londinese, per esempio secondo Hasuike, comunque un grande patrimonio. Io vi posso parlare molto bene della storia, di come è nata questa collezione, e dirvi quello che a me risulta del suo futuro, perché sicuramente ne ha di futuro. Vorrei dirvi che questa collezione è molto ben esposta, o comunque correttamente esposta su 1600 mq presso la sede, nella sede, potremmo dire, della facoltà nuova di disegno industriale del Politecnico di Milano; e questo fatto, almeno di principio, lo trovo molto buono. Purtroppo è poco visitabile, mi dispiace molto che non lo sia stato per il regista di questa trasmissione. Sta di fatto che quella collezione, che rimane un contributo importante di livello internazionale, esiste e sta crescendo, perché da come era stata tenuta in esposizione presso la Triennale oggi dispone anche di un preziosissimo, nuovo contributo che è la famosa collezione dei modelli storici di Giovanni Sacchi che con accordi avvenuti recentemente è stata in effetti comperata dalla Regione di Milano [sic] e data in deposito – come ulteriore contributo storico – alla collezione storica della Triennale.»UG: «Quindi è importante che Milano si dia questo museo.»GB: «Io direi che c’è una cosa di cui parlavamo, e io ho scritto di questo anche sulle riviste di settore, visto che sono stato uno di quelli che ha forzato certe resistenze perché comunque si potesse portare in esposizione questo patrimonio storico. Dire che questa a oggi in questo momento è una grande potenzialità, è vero quello che dice Branzi che un museo non è solo una collezione, ma io credo per un museo occorre una collezione, che comunque è un elemento forte e importante di questo grande organismo che indubbiamente la Triennale sola non poteva e non è riuscita a sostenere.»UG: «Comunque datevi da fare perché alcuni segni fanno intendere che Roma “ladrona” sia in agguato. È vero Anna Del Gatto, autrice e curatrice del programma che introduce ora l’agguato romano…»Anna Del Gatto: «Sì, Ugo, senti io vorrei interrompere un momento per dire che nel pubblico è arrivato ora Giovanni Sacchi, che era stato citato adesso da Bosoni e quindi volevo fargli un omaggio perché è una persona grande per tutti noi…»[applauso]Giovanni Sacchi: «Potrei dire che sono il museo del design. Io son nato costruendo modelli per fonderie. Poi l’incontro causale [sic] con Nizzoli negli anni cinquanta mi ha portato a trasformarmi nel designer. Posso dire che da me sono passati tutti i designer italiani, specialmente i milanesi – vedo delle facce note che hanno studiato con Nizzoli. Abbiamo creato tanti modelli, abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo disperso un patrimonio di lavoro… perché? Non c’è mai stata una raccolta di questo. Cinquant’anni che predico questo museo… non un museo perché è un museo… Nel conservare questo fattore di lavoro che hanno fatto questi designer italiani, che hanno sviluppato nel mondo intiero la loro intelligenza… non si può nascondere: la moda ha fatto il suo passo, ma il design ha fatto di più della moda, perché l’industria italiana con il designer si è evoluta in tutti i campi e fa fede ancora oggi il nostro designer. Vediamo ancora i nostri designer richiesti. Guardate che oggi da me c’erano 40 finlandesi. Perché vengono da me? Perché manca l’incontro scuola e lavoro… Domani io vado in Svizzera, perché mi hanno invitato; e perché questo invito come persona unica? Perché il design italiano è stato lì, messo da parte, non lo abbiamo mai sviluppato per quello che era, per quello che è. E tuttora il designer italiano è alla testa del lavoro italiano. Non c’è un prodotto che non sia disegnato da un designer italiano. E questa è una evoluzione che bisogna conservarla, anche con il museo, partendo naturalmente dai prototipi, dallo studio del lavoro che fa il designer… non è che disegna perfettamente e basta: il designer costruisce man mano che il lavoro nasce; il modello nasce in base all’idea del designer.»UG: «Bene, sentiamo Sandra Pinto, direttrice della Galleria nazionale di arte moderna di Valle Giulia a Roma.»Sandra Pinto [testimonianza video]: «Il progetto vincitore è un progetto che ha perfettamente inteso lo spirito; è un progetto di ingegneria istituzionale altrettanto difficile quanto il tema architettonico. Si tratta infatti adesso di passare da un’idea generale a un’idea di dettaglio e molto precisata su un qualcosa che non è un museo e non è una università ma è un grande centro di produzione della cultura contemporanea, in cui il momento della creazione, il momento dell’informazione, il momento dello scambio interattivo tra l’arte, la società e la cultura si cristallizza il minuto successivo in una forma di memoria e di museo. Certamente è importante che ci si possa confrontare su tutto poi il vasto patrimonio di fatti che interessano la cultura contemporanea. Il centro lo farà con un polo importante per la ricerca e anche per la ricerca avanzata, come pure con gli strumenti da portare a immediata disposizione del pubblico. Sia il progetto architettonico sia il progetto istituzionale lavora su un concetto di navigazione, come se fossimo in una sorta di internet ma in uno spazio reale non in uno spazio virtuale. Le domande da porsi interrelatamente fra una forma artistica e l’altra, fra una disciplina e l’altra, fra un medium e l’altro dovrebbero avvenire nello spazio grande ma non grandissimo di 27.000 mq.»UG: «Il professor Gillo Dorfles, diciamo l’ornamento maggiore di questo incontro di oggi…»Gillo Dorfles: «Non esageriamo, non esageriamo soprattutto…»UG: «No, no, come non esageriamo… Penso siamo tutti d’accordo. Questo mito del design milanese ha ragione di continuare, come dire, nel suo rigoglio?»GD: «Sì per una volta una fama non è usurpata. Bisogna riconoscere che Milano ha avuto la straordinaria fortuna, più che abilità, di inventare il design quando ancora in Italia non si sapeva che cosa fosse. In un certo senso Milano ha fatto il design e solo dopo cinque o sei anni si è accorta che si trattava di design. Molti industriali milanesi avevano degli studi, ricorrevano a professionisti, soprattutto architetti, e non sapevano neanche che la parola “design” volesse dire quello che oggi sappiamo voglia dire. Difatti per molto tempo si è discusso: bisogna dire “disegno industriale” o bisogna dire “design”? Ma a parte questo, non c’è dubbio che Milano da cinquant’anni a questa parte è la capitale del design, è quella che ha dato maggiore apporto, maggiori scoperte formali in questo campo. E difatti anche all’estero quasi tutti riconoscono a Milano questa caratteristica.»UG: «Qual è la peculiarità naturale che consente al design milanese di essere così universale?»GD: «Io credo che è dovuta all’incontro di una sufficiente attenzione alla funzione, alla funzionalità degli oggetti, come del resto anche i giapponesi, gli americani, i tedeschi sanno fare, e una inventiva che è particolare del designer italiano. Quindi questo incontro delle due cose, che a volte ha dato origine anche a degli scontri sanguinosi, ha fatto sì che sono venuti alla luce degli oggetti del tutto particolare che non avrebbero mai potuto avere natali in Germania, o America e neppure in Inghilterra.»UG: «Quindi il design milanese affonda le radici nella grande tradizione italiana…»GD: «… in fondo gli italiani di oggi, che non sono più i grandi pittori del Rinascimento, che non sono più i grandi architetti barocchi, che non sono più i grandi artisti di un millennio, nel campo del design hanno ritrovato le radici che pareva avessero perduto.»UG: «E quindi questo museo del design?»GD: «Eh, qui il problema, perché bisogna intendersi prima di tutto su che cosa è o dovrebbe essere il museo del design. Perché non basta mettere un migliaio di oggetti uno accanto all’altro – cosa che per conto mio è sbagliata – bisogna trovare il modo che il museo del design abbia i prototipi fondamentali ma abbia anche i progetti, abbia anche i disegni esecutivi, abbia anche tutto quell’insieme di materia preparatoria al design che è fondamentale. Per questo prima di dire “museo di design” bisognerebbe decidere come sarà o sarebbe questo design: come il Victoria&Albert Museum o come la raccolta archivio di Quintavalle a Parma? Sono due poli che possono confluire in un museo del design.»UG: «O come il museo di Groningen in Olanda, del quale ora vedremo le immagini e poi così a sorpresa vi diremo chi è e dove sta l’autore.»[immagini del museo di Groningen]UG: «L’autore di questo mitico museo del quale abbiamo assaporato una specie di videoclip è qui seduto accanto a me ed è l’architetto Alessandro Mendini, diciamo, la cui fama è talmente vasta e salda, che è superfluo che io la riconfermi. Ecco, architetto, come è stata l’esperienza della costruzione di questo museo? Lei ha avuto anzitutto un committente nella persona del suo direttore, il soprintendente, il signore [Frans] Haks, con il quale ha in qualche modo concertato l’impostazione…»Alessandro Mendini: «Sì esatto. L’avventura bellissima – il museo adesso ha cinque anni – è cominciata quando questo signor Haks ha suonato il campanello del mio studio e mi ha chiesto di progettargli il museo della città di Groningen, che è un museo che va dalla archeologia a una pinacoteca, a dei padiglioni fino all’arte contemporanea. Appunto perché diviso in padiglioni specializzati è una specie di somma di piccoli musei che danno luogo a un macromuseo, a una sintesi. Sulla base di questa situazione anche proprio urbanistica abbiamo deciso di invitare alcuni architetti ospiti, per cui l’architettura è una somma di architetture contemporanee di diversa caratteristica linguistica e pertanto lo stesso museo si presenta in maniera “automuseale”… come potrei dire…»UG: «Lei è stato l’architetto padre…»AM: «Sono il coordinatore generale di tutta questa cosa complessa.»UG: «… che ha ricostituito intorno a questa impresa quello che ‘è il suo habitat naturale di lavoro, che è l’atelier.»AM: «Sì, io sono abituato e mi interessa anche molto lavorare con persone diverse, nel senso che abbiano la testa anche molto diversa dalla mia, e pertanto i miei lavori in genere sono dei patchwork…»UG: «… però lei ha detto “purché imparino l’alfabeto” cioè l’alfabeto di Mendini…»AM: «Beh sì, c’è di mezzo evidentemente una specie di necessità di sintesi per arrivare a un obiettivo che rimane però sempre un po’ aperto perché non si ha mai l’ultima parola nel momento in cui lavorano creativamente anche gli altri.»UG: «Ed è stato edificato su un’isola artificiale al centro di un canale altrettanto artificiale.»AM: «Sì, come succede in Olanda, questo museo è nell’acqua, è un’isola fra due ponti dei quali uno levatoio perché tanto passano le navi; si stanno progettando probabilmente anche dei padiglioni a zattera che possono arrivare anche magari a Amsterdam o più lontano…»UG: «Le piacerebbe costruire il museo del design di Milano?»AM: «No. Io mi sono occupato del museo… di musei di design a Milano, penso, per trent’anni: ogni anno ne saltava fuori uno; ho cominciato con Gio Ponti e con Roberto Olivetti, e con Dorfles anche, e progressivamente mi sono assolutamente defaticato e non mi interessa sentire parlare di museo di design a Milano.»UG: «Mentre invece altrove sì?»AM: «Dove c’è qualche speranza, perché qui la speranza, secondo me, nonostante quello che dice Bosoni non c’è.»UG: «Ho capito. Sentiamo adesso un’altra rapida testimonianza di un ospite “riprodotto”, Vittorio Fagone, critico d’arte e direttore della galleria, della Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo.»Vittorio Fagone [testimonianza video]: «Quando nel 1995 ho potuto dedicare una mostra a Gianni e Joe Colombo, lo sconcerto di alcuni visitatori che, abituati a visitare uno spazio museale vi trovavano esposti degli oggetti, e qualcuno diceva “Mah, il museo è diventato la Rinascente”, questo dato di contemporaneità, a mio giudizio, contemporaneità in cui si trovano il fruitore e il progettista, è il dato più affascinante dell’universo del design.»UG: «Stefano Casciani, giornalista, esperto di design e architetto coautore del nostro programma. Come mai gli architetti italiani costruiscono musei all’estero e i nostri musei vengono progettati dagli stranieri, per esempio l’architetta [sic] Aziz [sic] [2xsic=sigh] che ha vinto il concorso per il nuovo centro di arte contemporanea romano.»Stefano Casciani: «Questa che tu sollevi è una polemica ormai di livello internazionale. Ho scovato l’altro giorno su internet una notizia deliziosa a proposito delle polemiche che stanno sorgendo negli stati uniti a Chicago perché Renzo Piano ha vinto un concorso internazionale per l’estensione dell’Art Institute di Chicago, che è uno dei musei più belli degli Stati Uniti. Negli stessi giorni iniziava anche a serpeggiare una polemica anche piuttosto pesante fatta da alcuni baroni dell’architettura italiana contro Zaha Hadid che ha avuto il coraggio di vincere il concorso per il centro internazionale delle arti contemporanee di Roma. Io credo che di fronte al fenomeno della globalizzazione tutte queste polemiche siano piuttosto ridicole e vogliano soltanto cercare di mantenere un impossibile equilibrio geografico culturale. Quindi mi sembra che il problema del museo ritorni comunque sulla centralità del problema dell’oggetto. Studiando questo problema per questa mostra con la galleria nazionale delle arti moderne di Roma, il dato interessante è proprio quello del ritorno del pubblico all’interesse verso l’oggetto. Paola Antonelli ha organizzato per il Museum of Modern Art di New York una mostra di Achille Castiglioni che ha avuto 100mila visitatori. Con Alessandro Mendini abbiamo realizzato una mostra al Louisiana Museum di Copenaghen sul design italiano e sul design europeo che ha avuto 106mila visitatori in tre mesi. Questi mi sembrano dati comunque positivi e interessanti, è forse su questo che ci dobbiamo concentrare per capire l’attualità e centralità dello specifico degli oggetti nei musei.»UG: «Franco Origoni, graphic designer, anche lei è d’accordo sulla necessità che si istituisca un msueo del design.»Franco Origoni: «Per fare il museo del design secondo me bisogna ricordarsi di un pezzettino che c’è in Nuovo cinema Paradiso di Tornatore, dove al ragazzo che ha nostalgia della Sicilia gli si dice “non ti voltare mai e vai avanti”. Cioè se vogliamo fare un museo del design in Italia è chiaro dobbiamo dimenticarci delle logiche che si intrecciano e che hanno impedito al museo di vivere. Ci sono le collezioni di design ormai diffuse; se citiamo oltre alle collezioni particolari dell’Alessi, c’è l’Alfa Romeo, c’è la Fiat, c’è la Caproni, ci sono una quantità di aziende che prima che fosse fatta la legge e dopo hanno messo insieme le loro collezioni… per cui quello che manca è un motore che ragioni sulla natura del design, sul ruolo del design e su che cosa è il design oggi. Non è un luogo fisico, il luogo fisico c’è e se ne trova… c’è una collezione straordinaria che va rivalutata.»UG: «E le cause che fino a oggi hanno impedito la realizzazione di questo…»FO: «Beh la concezione innanzi tutto del museo ottocentesco. Non voglio fare adesso una disquisizione filosofica su questa cosa però se si pensa che i musei di design sono una sequenza di oggetti esposti in maniera stabile in una teca fantastica, illuminati con una illuminazione bellissima, questo è un museo che è morto già dall’inizio. Il museo è un pezzo di serie, e non è comunque anche quando è un segno molto forte un pezzo unico come può essere un Piero della Francesca. Il rapporto nei musei d’arte – credo che Paola Antonelli ne sappia più di me – fra la parte di collezione e la parte esposta in maniera permanente si calcola nella progettazione dei musei nel rapporto di uno a cinque, cioè se ci sono mille metri quadri di esposizione ce ne sono cinquemila di organizzazione per fare funzionare il museo. Ci sono equipe che fanno funzionare il museo, che fanno ruotare le mostre sulla stessa collezione… Forse a questo bisognerebbe pensare, non alle polemiche che inseguiamo tutti i giorni.»UG: «Bene. Chiudiamo con un’ultima testimonianza registrata. Giulio Castelli, imprenditore: il museo del design che vorrebbe.»Giulio Castelli: «È molto più interessante avere un museo virtuale. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia del design, di un designer, e dei disegni tecnici di questo prodotto, e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti per poterlo guardare realmente. Ecco questo sarebbe secondo me l’ideale. Forse con i mezzi futuri, visto che si fanno i magazzini che schiacciando i bottoni si fanno le spedizioni, perché non si deve poter avere un magazzino dove schiacciando un bottone ci sia un nastro, un tapis roulant che porti questo pezzo davanti allo studente o al ricercatore o allo studioso.»
Creazione 7 giorni su 7
Creation Museum
Negli ultimi giorni, utilizzando come chiave di ricerca la parola “museum” in YouTube il primo risultato che compare è un servizio riguardante il Creation Museum (Petersburg, Ky, non lontano da Cincinnati, Oh), lo spettacolare “parco dei divertimenti” – ché non altro pare essere – realizzato da Answers in Genesis («an apologetics [i.e. Christianity-defending] ministry, dedicated to enabling Christians to defend their faith») e costato ben 27 milioni di dollari.Secondo i creazionisti la Bibbia conterrebbe la storia precisa della vita sulla Terra, il Genesi – e non Darwin – spiegherebbe l’origine del mondo. Per ciò nel Museo, attraverso 160 allestimenti, ci si trova immersi nell’epoca in cui Adamo e Eva erano nel Giardino e i dinosauri erano… loro amici.Una passeggiata attraverso la storia (?) realizzata con ogni mezzo. Il progetto infatti vede il coinvolgimento di un ex direttore degli allestimenti degli Universal Studios, che ha messo a frutto, a quanto pare, ogni tecnica e sistema per assicurare una «fully engaging, sensory experience for guests. Murals and realistic scenery, computer-generated visual effects, over fifty exotic animals, life-sized people and dinosaur animatronics, and a special-effects theater complete with misty sea breezes and rumbling seats». Insomma, cosa desiderare di più? Con tutto questo, perfino a Adamo ed Eva passerà la voglia di allungar le mani verso l’Albero.Sugli obiettivi del museo la comunicazione ufficiale lascia poco spazio ai dubbi sulla convinzione (o furbizia estrema) dei promotori e curatori: «The Bible speaks for itself at the Creation Museum. We’ve just paved the way to a greater understanding of the tenets of creation and redemption. Our exhibit halls are gilded with truth, our gardens teem with the visible signs of life».D’altronde il polso della situazione, di dove vada l’opinione comune, americana, può forse essere dato semplicemente in termini economici. Nel 2005-2006 per la mostra dedicata dall’American Museum of Natural History (New York) a Darwin, come ci ricorda un articolo di Riccardo Staglianò ancora online, «non un’azienda statunitense si è fatta avanti per finanziare almeno in parte i tre milioni di dollari che l’esposizione è costata»; mentre, a fronte di un 51% della popolazione che, stando a un sondaggio Cbs, dichiarava di non credere alla teoria della selezione naturale, le aziende avrebbero preferito riservare le loro donazioni alle «tesi vincenti», come appunto il Museo creazionista.E in effetti, a scorrere il colophon della mostra su Darwin (in calce al sito web), non vi è immediata traccia di sponsor aziendali, bensì di fondazioni e privati.Una nota. Fra gli spettacoli che illustrano i temi del Creation Museum e del creazionismo uno in particolare riguarda i Six Days in Creation. Nonostante ciò, il museo rimane aperto 7 giorni su 7…A questo proposito ci piace ricordare che Charles Baudelaire, più avveduto, ricordava a se stesso, in Mon coeur mis à nu (Il mio cuore messo a nudo), XCI: «Lavora sei giorni senza interruzione».