 Nel campo musicale featuring indica la partecipazione – in varia misura – di un artista a un brano eseguito principalmente da altri. In alcuni casi si tratta di una sorta di “tributo” in altri di vera e propria collaborazione. In qualche modo, di una interpretazione.Che una esposizione possa nascere da un’interpretazione a più voci non è inusuale, basta pensare alle mostre con più curatori. Al centro del loro lavoro – non la musica e le note ma – artefatti e opere, collezioni, patrimoni. Quando non si tratti di esposizioni confezionate ad hoc, però, ovvero quando si tratti di collezioni permanenti, è ancora più interessante osservare la pratica, da parte di musei e istituzioni di chiamare visiting (guest) curators a cui affidare lo studio, la lettura e il racconto. Come per i visiting professors, si tratta di un’occasione più o meno prolungata che onora chi ne è investito, e parimenti ne riconosce il valore o l’autorità. Interessante pratica perché si riallaccia ai fondamenti delle istituzioni museali, intese come luogo non solo di conservazione ma anche di produzione e diffusione culturale; e inoltre perché – certo con le dovute distinzioni – attinge al principio della pluralità di voci e della condivisione delle fonti e dei saperi.Nella nostra immaginazione simili iniziative, che nella realtà probabilmente sono anche connotate da aspetti burocratici e “politici”, ci appaiono come un invito, un’ospitalità di estreme generosità e apertura, quello cioè rivolto ad altri perché venga in casa nostra per dare una interpretazione di ciò che vi trova o magari perfino di noi stessi.Varianti di queste formule sono quelle in cui – come nella musica di cui si diceva supra – si fa appello e si “sfrutta” in qualche modo il nome dell’interprete, che sia del settore. Il museo d’arte può chiamare l’artista, così come un museo del design può chiamare un designer.Così ha fatto il Cooper Hewitt National Design Museum (Smithsonian Institution) a New York, che ha chiamato alcuni guest curators per alcune mostre temporanee. Il più recente è lo studio Ideo che ha esplorato la collezione permanente del museo realizzando una mostra incentrata sul tema design thinking – fino al 20 gennaio 2008 presso la Nancy and Edwin Marks Gallery, ma anche con possibilità di visita virtuale online. Come riportato nella home del sito dedicato, «to represent design thinking, Ideo chose objects that demonstrate innovative problem solving over the past five centuries. Ideo uses three lenses – Inspiration, Empathy, and Intuition – to explore these objects and the very human impulses that motivate designers and the contexts in which objects are created and used». È Tim Brown, presidente di Ideo, a spiegare le finalità di questa operazione, tracciando un rapido arco della propria vita da designer, delle esperienze che lo hanno condotto a comprendere ben presto – dopo la laurea a Londra negli anni ottanta – che «design is about far more than form giving. It is about understanding the needs of individuals and groups and working to create responses that really meet those needs both functionally and emotionally. It is about investing as much in the idea as in the form. It is about exploiting the essential optimism of design thinking to explore possibilities that do not occur to those who only take an analytical view. It is about responding to the challenges of the present by imagining the possibilities of the future».La mostra si ancora dunque con intento propositivo nell’attualità e nel contemporaneo: l’obiettivo è non solo mostrare come il design thinking – certo non sempre consapevole come in questa espressione – sia stato applicato o sia comunque entrato in gioco nella ideazione e realizzazione di molti prodotti, ma anche «illustrate how you might apply some of these aspects of design thinking to your own creative challenges».Come emerge chiaramente dall’allestimento – visibile dalla virtual exhibit – non pare che siano state intraprese particolari soluzioni per esplicitare il processo del design thinking. Il che è comprensibile, considerato che in questi casi il guest curator è chiamato, in qualche modo, a estrarre dei pezzi dalle collezioni (Ideo Selects è il titolo dell’esposizione), e comporli secondo la propria interpretazione. I prodotti, entro vetrine o su pedane, sono invece accompagnati da didascalie (le stesse del sito, crediamo) che traducono in testo da leggere non solo i dati “biografici” (designer, anno, produttore, nazione, materiali) ma soprattutto la posizione rispetto alle tre coordinate – i curatori parlano di lens – assunte dai curatori per illustrare il design thinking, ovveroInspiration: «how designers respond to the materials, technology, people, and social and cultural contexts of their time»;Empathy: «how designers imagine people will benefit from their ideas based on the needs at hand»;Intuition: «how designers’ intent and personal frameworks drive their vision of the outcome».Non tutti i pezzi presenti, del resto, sono rappresentativi di tutte tre queste modalità. Per esempio, a differenza di Valentine di Sottsass, il calcolatore Divisumma 18 disegnato da Bellini presenta il riferimento solo a Empathy, essendo concepito primariamente quale prodotto per un ufficio tecnologico “completamente umanizzato”. Viceversa, una poltroncina per lettura, inglese e settecentesca, viene descritta solo in termini di Inspiration, come pure avviene per la Radio portatile TS 502 di Sapper e Zanuso, magari con un po’ di semplificazione: «As colorful plastics were hitting their stride in the 1960s, designers Richard Sapper ad Marco Zanuso were expanding their use in consumer goods such as the ts502 radio. Not unlike its modernist furniture counterparts, the radio had a soft-edged, glossy aesthetic which spoke of the future, James Bond films, and casual irreverence».Comunque, con i dubbi che pure si possono avere, la visita virtuale vale la pena. Fra l’altro è possibile non solo commentare le schede dei pezzi – operazione interessante, come se ogni opera esposta avesse un guest book, in cui lasciare le proprie annotazioni (la scheda di catalogo si è ormai trasformata in post di un blog!) – ma anche, nella sezione In the World, aggiungere immagini di prodotti, oggetti da candidare per l’inserimento nello slideshow. Naturalmente precisando di quale lente si voglia dare esemplificazione: Ispirazione, Empatia o Intuizione?
Nel campo musicale featuring indica la partecipazione – in varia misura – di un artista a un brano eseguito principalmente da altri. In alcuni casi si tratta di una sorta di “tributo” in altri di vera e propria collaborazione. In qualche modo, di una interpretazione.Che una esposizione possa nascere da un’interpretazione a più voci non è inusuale, basta pensare alle mostre con più curatori. Al centro del loro lavoro – non la musica e le note ma – artefatti e opere, collezioni, patrimoni. Quando non si tratti di esposizioni confezionate ad hoc, però, ovvero quando si tratti di collezioni permanenti, è ancora più interessante osservare la pratica, da parte di musei e istituzioni di chiamare visiting (guest) curators a cui affidare lo studio, la lettura e il racconto. Come per i visiting professors, si tratta di un’occasione più o meno prolungata che onora chi ne è investito, e parimenti ne riconosce il valore o l’autorità. Interessante pratica perché si riallaccia ai fondamenti delle istituzioni museali, intese come luogo non solo di conservazione ma anche di produzione e diffusione culturale; e inoltre perché – certo con le dovute distinzioni – attinge al principio della pluralità di voci e della condivisione delle fonti e dei saperi.Nella nostra immaginazione simili iniziative, che nella realtà probabilmente sono anche connotate da aspetti burocratici e “politici”, ci appaiono come un invito, un’ospitalità di estreme generosità e apertura, quello cioè rivolto ad altri perché venga in casa nostra per dare una interpretazione di ciò che vi trova o magari perfino di noi stessi.Varianti di queste formule sono quelle in cui – come nella musica di cui si diceva supra – si fa appello e si “sfrutta” in qualche modo il nome dell’interprete, che sia del settore. Il museo d’arte può chiamare l’artista, così come un museo del design può chiamare un designer.Così ha fatto il Cooper Hewitt National Design Museum (Smithsonian Institution) a New York, che ha chiamato alcuni guest curators per alcune mostre temporanee. Il più recente è lo studio Ideo che ha esplorato la collezione permanente del museo realizzando una mostra incentrata sul tema design thinking – fino al 20 gennaio 2008 presso la Nancy and Edwin Marks Gallery, ma anche con possibilità di visita virtuale online. Come riportato nella home del sito dedicato, «to represent design thinking, Ideo chose objects that demonstrate innovative problem solving over the past five centuries. Ideo uses three lenses – Inspiration, Empathy, and Intuition – to explore these objects and the very human impulses that motivate designers and the contexts in which objects are created and used». È Tim Brown, presidente di Ideo, a spiegare le finalità di questa operazione, tracciando un rapido arco della propria vita da designer, delle esperienze che lo hanno condotto a comprendere ben presto – dopo la laurea a Londra negli anni ottanta – che «design is about far more than form giving. It is about understanding the needs of individuals and groups and working to create responses that really meet those needs both functionally and emotionally. It is about investing as much in the idea as in the form. It is about exploiting the essential optimism of design thinking to explore possibilities that do not occur to those who only take an analytical view. It is about responding to the challenges of the present by imagining the possibilities of the future».La mostra si ancora dunque con intento propositivo nell’attualità e nel contemporaneo: l’obiettivo è non solo mostrare come il design thinking – certo non sempre consapevole come in questa espressione – sia stato applicato o sia comunque entrato in gioco nella ideazione e realizzazione di molti prodotti, ma anche «illustrate how you might apply some of these aspects of design thinking to your own creative challenges».Come emerge chiaramente dall’allestimento – visibile dalla virtual exhibit – non pare che siano state intraprese particolari soluzioni per esplicitare il processo del design thinking. Il che è comprensibile, considerato che in questi casi il guest curator è chiamato, in qualche modo, a estrarre dei pezzi dalle collezioni (Ideo Selects è il titolo dell’esposizione), e comporli secondo la propria interpretazione. I prodotti, entro vetrine o su pedane, sono invece accompagnati da didascalie (le stesse del sito, crediamo) che traducono in testo da leggere non solo i dati “biografici” (designer, anno, produttore, nazione, materiali) ma soprattutto la posizione rispetto alle tre coordinate – i curatori parlano di lens – assunte dai curatori per illustrare il design thinking, ovveroInspiration: «how designers respond to the materials, technology, people, and social and cultural contexts of their time»;Empathy: «how designers imagine people will benefit from their ideas based on the needs at hand»;Intuition: «how designers’ intent and personal frameworks drive their vision of the outcome».Non tutti i pezzi presenti, del resto, sono rappresentativi di tutte tre queste modalità. Per esempio, a differenza di Valentine di Sottsass, il calcolatore Divisumma 18 disegnato da Bellini presenta il riferimento solo a Empathy, essendo concepito primariamente quale prodotto per un ufficio tecnologico “completamente umanizzato”. Viceversa, una poltroncina per lettura, inglese e settecentesca, viene descritta solo in termini di Inspiration, come pure avviene per la Radio portatile TS 502 di Sapper e Zanuso, magari con un po’ di semplificazione: «As colorful plastics were hitting their stride in the 1960s, designers Richard Sapper ad Marco Zanuso were expanding their use in consumer goods such as the ts502 radio. Not unlike its modernist furniture counterparts, the radio had a soft-edged, glossy aesthetic which spoke of the future, James Bond films, and casual irreverence».Comunque, con i dubbi che pure si possono avere, la visita virtuale vale la pena. Fra l’altro è possibile non solo commentare le schede dei pezzi – operazione interessante, come se ogni opera esposta avesse un guest book, in cui lasciare le proprie annotazioni (la scheda di catalogo si è ormai trasformata in post di un blog!) – ma anche, nella sezione In the World, aggiungere immagini di prodotti, oggetti da candidare per l’inserimento nello slideshow. Naturalmente precisando di quale lente si voglia dare esemplificazione: Ispirazione, Empatia o Intuizione?
Category: Design
Anything related to design
Cooper Hewitt feat. Ideo
Raccogliere, ordinare, raccontare
 Questa immagine pubblicata ieri in “La Repubblica” (Fabrizio Ravelli, Craiova, nella terra degli zingari. “I lavavetri? Chi ruba ci rovina”, p. 13) mostra l’interno di una abitazione di zingari in Romania. Il tema dell’articolo in cui compariva è serio, ma noi ci soffermiamo qui solo sulla foto: scodelle ordinate su più file in un equilibrio che a noi sembra precario, alle pareti cestini e scolapasta di plastica di differenti cromie, e ancora vasetti appesi grazie al manico, ciotole e pentole di metallo, verso il fondo tazzine che si confondono con le decorazioni della parete (o della tenda)…Tanti oggetti d’uso disposti con ordine. Che cosa raccontano? Abitudini e costumi, status sociale, decoro ed etica, aspirazioni di una famiglia, di un gruppo. E il loro racconto, immediato e vivo, si dispiega proprio nell’uso che di essi viene fatto, nel loro disporsi all’intervento ordinatore di chi li possiede – che con essi non solo compie azioni quotidiane ma comunica se stesso.L’immagine ci fa venire in mente molte infilate di pezzi più o meno preziosi ormai sottratti all’uso e collocati in vari musei di arti decorative, di quelli che spesso non è possibile neppure fotografare – divieto che ci pare sempre meno comprensibile, in particolare in musei di arti applicate e decorative (recentemente abbiamo visitato quello di Padova dove, appunto, non è consentito scattare alcuna fotografia).
Questa immagine pubblicata ieri in “La Repubblica” (Fabrizio Ravelli, Craiova, nella terra degli zingari. “I lavavetri? Chi ruba ci rovina”, p. 13) mostra l’interno di una abitazione di zingari in Romania. Il tema dell’articolo in cui compariva è serio, ma noi ci soffermiamo qui solo sulla foto: scodelle ordinate su più file in un equilibrio che a noi sembra precario, alle pareti cestini e scolapasta di plastica di differenti cromie, e ancora vasetti appesi grazie al manico, ciotole e pentole di metallo, verso il fondo tazzine che si confondono con le decorazioni della parete (o della tenda)…Tanti oggetti d’uso disposti con ordine. Che cosa raccontano? Abitudini e costumi, status sociale, decoro ed etica, aspirazioni di una famiglia, di un gruppo. E il loro racconto, immediato e vivo, si dispiega proprio nell’uso che di essi viene fatto, nel loro disporsi all’intervento ordinatore di chi li possiede – che con essi non solo compie azioni quotidiane ma comunica se stesso.L’immagine ci fa venire in mente molte infilate di pezzi più o meno preziosi ormai sottratti all’uso e collocati in vari musei di arti decorative, di quelli che spesso non è possibile neppure fotografare – divieto che ci pare sempre meno comprensibile, in particolare in musei di arti applicate e decorative (recentemente abbiamo visitato quello di Padova dove, appunto, non è consentito scattare alcuna fotografia). Questa immagine l’abbiamo invece scattata al Musée des arts décoratifs di Parigi – dove per fortuna non c’è alcun divieto in merito, e si può inoltre agevolmente ritrovare gli oggetti esposti anche nel catalogo online del sito web.Una suggestiva serie di boccette, presse-papier, flaconi… sottoposti agli usi e consumi museali, ovvero a essere guardati nel complesso come una tavolozza di colori e di forme, oppure riguardati con ammirazione da visitatori per lo più accompagnati da audioguida individuale. Che cosa raccontano? È un racconto per nulla im-mediato, e ben poco “vivo”. Sia perché si tratta di artefatti lontani (nel tempo e nello spazio; e su simili distanze, sempre restando a Parigi, si pensi per esempio al Musée du Quai Branly), di cui a volte possiamo faticare a riconoscere e comprendere l’utilizzo e la fattura, sia perché nei musei il faticoso lavoro curatoriale che si colloca fra i termini della meraviglia e della risonanza, della sacralizzazione e della contestualizzazione, e oltre, si trova sovente a dover operare scelte, talora compromessi, al fine di giungere a offrire una forma di esposizione, racconto e comunicazione. Per cui, se spesso ci accade pure di pensare «Questa esposizione poteva o doveva essere fatta altrimenti», o di maturare fra noi qualche critica, alla fine dei conti riconosciamo sopra ogni dubbio, e con gioia, la fortuna che i musei ci siano, e che qualcuno ci provi a mostrare e raccontare – anziché tentennare lasciando le opere nei magazzini. Non per questo vogliamo ignorare il rilievo e la responsabilità che il ruolo del curatore possiede, anzi. Ma la fortuna è anche quella che ci sia ancora spazio per raccontare in maniera diversa, per costruire “altri” racconti, sia da parte dei curatori e degli studiosi, sia da parte dei visitatori stessi per i quali un’esposizione non condivisa o ritenuta carente potrà almeno fungere da stimolo: perché avrà veduto, e – esprimendoci al limite – non potrà ignorare l’esistenza di un oggetto prima sconosciuto al suo universo.Per tornare all’immagine, il racconto che la visione – e la ricezione con più sensi – di una tale esposizione di oggetti svolge si compone dunque di diversi livelli: quello che viene proposto al visitatore, in forme più o meno articolate (con didascalie, pannelli, audioguide ecc.), ma pure quello – che con un po’ di allenamento si può ricavare – relativo alle intenzioni dei curatori. Il racconto del racconto. Naturalmente i due racconti sono in qualche modo sovrapposti e coincidenti, ma si deve guardarli con occhi differenti e con differente disponibilità all’abbandono. Senza voler dire, si badi bene, che il museo è un testo o i curatori propriamente scrittori, l’opera che viene allestita nei musei ha e deve avere una consapevole valenza autoriale. Il visitatore non dovrebbe ignorarlo, e dovrebbe invece moltiplicare il proprio sguardo sulle esposizioni che visita.La mediazione che un curatore, un museo, opera sugli oggetti dovrebbe rendere conto di se stessa, spiegarsi, rendersi comprensibile. Raccogliere e ordinare oggetti in un museo è altra cosa dal mettere in ordine piatti e pentole in casa propria.
Questa immagine l’abbiamo invece scattata al Musée des arts décoratifs di Parigi – dove per fortuna non c’è alcun divieto in merito, e si può inoltre agevolmente ritrovare gli oggetti esposti anche nel catalogo online del sito web.Una suggestiva serie di boccette, presse-papier, flaconi… sottoposti agli usi e consumi museali, ovvero a essere guardati nel complesso come una tavolozza di colori e di forme, oppure riguardati con ammirazione da visitatori per lo più accompagnati da audioguida individuale. Che cosa raccontano? È un racconto per nulla im-mediato, e ben poco “vivo”. Sia perché si tratta di artefatti lontani (nel tempo e nello spazio; e su simili distanze, sempre restando a Parigi, si pensi per esempio al Musée du Quai Branly), di cui a volte possiamo faticare a riconoscere e comprendere l’utilizzo e la fattura, sia perché nei musei il faticoso lavoro curatoriale che si colloca fra i termini della meraviglia e della risonanza, della sacralizzazione e della contestualizzazione, e oltre, si trova sovente a dover operare scelte, talora compromessi, al fine di giungere a offrire una forma di esposizione, racconto e comunicazione. Per cui, se spesso ci accade pure di pensare «Questa esposizione poteva o doveva essere fatta altrimenti», o di maturare fra noi qualche critica, alla fine dei conti riconosciamo sopra ogni dubbio, e con gioia, la fortuna che i musei ci siano, e che qualcuno ci provi a mostrare e raccontare – anziché tentennare lasciando le opere nei magazzini. Non per questo vogliamo ignorare il rilievo e la responsabilità che il ruolo del curatore possiede, anzi. Ma la fortuna è anche quella che ci sia ancora spazio per raccontare in maniera diversa, per costruire “altri” racconti, sia da parte dei curatori e degli studiosi, sia da parte dei visitatori stessi per i quali un’esposizione non condivisa o ritenuta carente potrà almeno fungere da stimolo: perché avrà veduto, e – esprimendoci al limite – non potrà ignorare l’esistenza di un oggetto prima sconosciuto al suo universo.Per tornare all’immagine, il racconto che la visione – e la ricezione con più sensi – di una tale esposizione di oggetti svolge si compone dunque di diversi livelli: quello che viene proposto al visitatore, in forme più o meno articolate (con didascalie, pannelli, audioguide ecc.), ma pure quello – che con un po’ di allenamento si può ricavare – relativo alle intenzioni dei curatori. Il racconto del racconto. Naturalmente i due racconti sono in qualche modo sovrapposti e coincidenti, ma si deve guardarli con occhi differenti e con differente disponibilità all’abbandono. Senza voler dire, si badi bene, che il museo è un testo o i curatori propriamente scrittori, l’opera che viene allestita nei musei ha e deve avere una consapevole valenza autoriale. Il visitatore non dovrebbe ignorarlo, e dovrebbe invece moltiplicare il proprio sguardo sulle esposizioni che visita.La mediazione che un curatore, un museo, opera sugli oggetti dovrebbe rendere conto di se stessa, spiegarsi, rendersi comprensibile. Raccogliere e ordinare oggetti in un museo è altra cosa dal mettere in ordine piatti e pentole in casa propria.
Centri e Musei. #2
Design
 Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.
Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.
Memorie di cose
Non briciole insipide, ma un unico pane
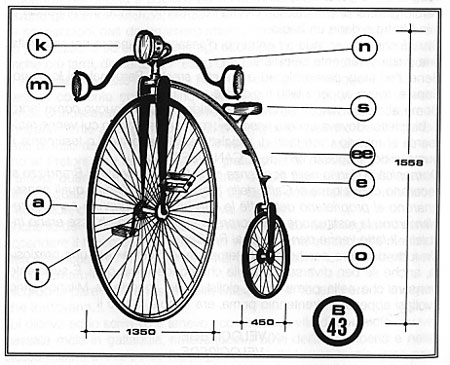 Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49).
Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49).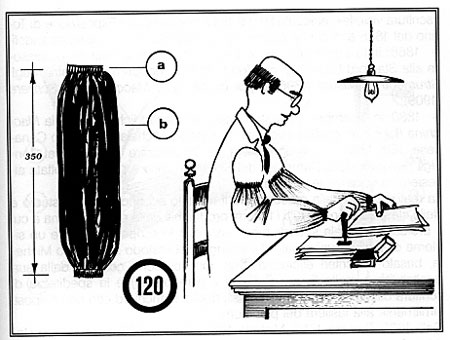 Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248).
Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248).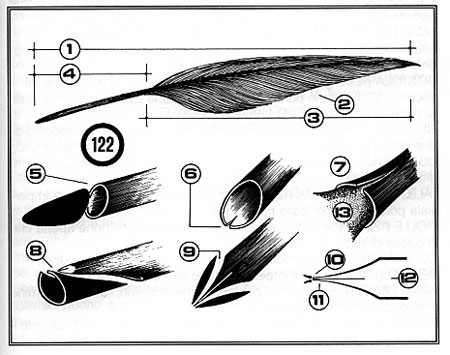 Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».
Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».
Musei?
Questione di lessico, ma non solo…
 Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.
Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.