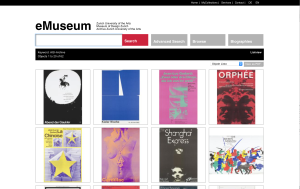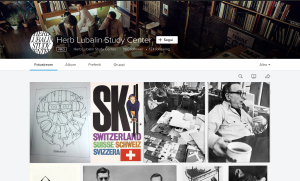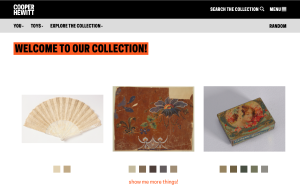Per discutere di storia digitale del design, è bene cominciare parlando di fonti, che sono centrali per fare la storia, e di archivi comprensivamente intesi come quelle istituzioni che sono preposte a conservare, gestire e offrire accesso alle fonti.
L’avvento del digitale ha avuto un notevole impatto su archivi, biblioteche e musei, che si sono trovati a dover ripensare, quotidianamente, il loro ruolo e le loro funzioni. Di fronte a loro è stata tracciata una strada – spesso riassunta nella idea dell’“archivio vivo” o “animato”1 – che comporta un mutamento profondo di concezioni e pratiche, un cambiamento delle priorità e una trasformazione di quelle che erano differenze in convergenze. Si tratta di uno scenario in cui, più che sulla conservazione come valore in sé, l’accento viene posto sull’accesso, sulla distribuzione e sull’utilizzo di informazioni e materiali da parte di un pubblico esteso, senza più distinzioni di grado fra specialisti e non specialisti; tradizionali modelli di servizio e consultazione si integrano con possibilità di accesso in remoto, di condivisione e riutilizzo, e si sperimentano modalità di fruizione aumentate, favorendo il coinvolgimento del pubblico fra reale e virtuale, fisico e digitale, materiale e immateriali; nella produzione di contenuti, si punta sul processo più che sul prodotto e le istituzioni accettano di cedere (almeno entro certi limiti) una parte di controllo su proprietà e standard dei contenuti per favorire la costruzione condivisa e partecipata di conoscenza e progetti; in generale, si favorisce la collaborazione, l’interazione e la convergenza di interessi fra istituzioni, comunità e soggetti diversi, variamente dislocati nello spazio e nel tempo.
Naturalmente, uno scenario simile appare come un luogo ideale da abitare per chi si occupa di storia, in specie del graphic design. Si pensi, per fare qualche banale esempio, alla possibilità di svolgere ricerche preliminari attraverso cataloghi online, specialmente quando non si hanno fondi/finanziamenti o coperture istituzionali per spostarsi e svolgere periodi di residenza fuori sede o all’estero; esaminare da vicino singoli documenti utilizzando accurate riproduzioni digitali di artefatti e documenti, che permettono di cogliere dettagli altrimenti non evidenti; aggregare immagini e metadati relativi a testimonianze di diverse fasi della progettazione – un prodotto finito presente nella collezione di un museo, accanto a lettere e schizzi originali presenti in un fondo archivistico, e pagine di qualche rivista di settore in cui quel prodotto è stato presentato e discusso, consultabili attraverso mediateche digitali – ed espandere la possibilità di contestualizzare i documenti di studio restando seduti alla propria scrivania; esplorare e salvare collezioni di immagini di artefatti meno noti – oltre la più volte deprecata canonica ripetizione di prodotti iconici che si trovano in manuali a stampa – per arricchire in maniera mirata il proprio repertorio di riferimenti per l’insegnamento; oppure coinvolgere gli studenti in simili attività di costruzione di raccolte di riferimenti, seguendo criteri diversi.
Allo stesso tempo, in uno scenario in cui si prefigura l’esigenza di sviluppare modalità e strumenti differenti per dare accesso alla interpretazione e fruizione di documenti del passato, gli storici del graphic design potrebbero essere chiamati in causa, accanto a tecnici e programmatori, per concepire e scrivere progetti curatoriali e per ideare piattaforme di presentazione e racconto che stimolino a diversi livelli la partecipazione del pubblico, non solo specialistico.
(Nelle immagini e didascalie che seguono, alcune considerazioni, a partire da realtà presenti nella rete.)
Nel 2007 il Museum für Gestaltung di Zurigo – che possiede un importante patrimonio di grafica – e la Zürcher Hochschule der Künste, hanno lanciato il portale emuseum.ch, che permette non solo di esplorare le collezioni del museo secondo diverse chiavi di accesso. All’interno dei singoli record le descrizioni spesso non sono molto approfondite e le immagini sono a bassa risoluzione. Il dato interessante è che questo portale consente ai visitatori di crearsi (previa iscrizione gratuita) proprie raccolte di immagini. Come si potrebbe usare simile strumento con finalità educative, con gli studenti? E perché, in questo museo virtuale, non invitare appositamente storici, studiosi o esperti a curare percorsi su temi diversi, integrando le informazioni disponibili o sollecitando altri a partecipare?
A fronte di simili possibilità – e di altre che sono tutte da immaginare – la situazione reale è alquanto diversa. Vale la pena ritornare a quanto scriveva qualche anno fa Catherine de Smet nel suo articolo “Jeu de piste: Archives et collections” (2007) dove, concentrandosi sulla situazione francese ma sollevando questioni generali, osservava che “la reconnaissance du design graphique, en tant que corpus de création digne d’être conservé, est loin d’être acquise”.2 Certamente la irrilevanza della grafica e la mancanza di attenzione specializzata hanno conseguenze pesanti nel quadro delle politiche istituzionali di conservazione di documenti e materiali. Rispetto a questa condizione, se il digitale offre un enorme potenziale, allo stesso tempo accentua e moltiplica alcuni problemi, e ne pone di nuovi.
In primo luogo, è evidente, nessun accesso, uso, interpretazione, curatela è possibile laddove non ci sia, prima o contestualmente, un interesse ad acquisire e conservare. D’altra parte, tuttavia, anche quando materiali e documenti rilevanti per la storia del design grafico siano acquisiti, alla loro esistenza fisica non corrisponde automaticamente, di per sé, una esistenza/vita digitale. Come è noto, in molti casi la grafica si trova a essere acquisita incidentalmente, come testimonianza, da parte di istituzioni che hanno finalità e missioni diverse – dalle biblioteche a collezioni tematiche di ogni genere – e che dunque non necessariamente considerano aspetti e informazioni relativi al progetto grafico nelle loro schedature e nei metadati. Ed è chiaro che quel che non viene descritto, o taggato, rimane, in definitiva, invisibile: non è catturabile. Così le maschere e categorie di ricerca offerte dai cataloghi online di tali istituzioni possono risultare presso che inservibili o di limitata utilità per chi sia sulle tracce di informazioni su materiali e dati progettuali.
L’adozione di strumenti, standard, vocabolari di catalogazione non specificamente pensati per il graphic design può limitare l’utilizzo finale delle descrizioni e risorse eventualmente rese disponibili.
Il fondo di Robert Massin è conservato presso la mediateca Apostrophe di Chartres. La schedatura, simile a quella del materiale bibliotecario, apparentemente non segue criteri di gerarchia archivistica. Le maschere di ricerca non offrono categorie e chiavi di ricerca specifici per il progetto grafico, e sembrano al più utili per identificare la posizione fisica dei documenti. Inoltre, data la quantità di materiali – che viene implementata dallo stesso designer ancora vivente – non è prevista per ora la digitalizzazione, precludendo quindi la possibilità di ricercare o navigare seguendo parametri visivi.
Inoltre, anche quando ci sia un effettivo interesse istituzionale per il design grafico – per esempio nel caso dell’acquisizione di archivi personali di graphic designer – la quantità ed eterogeneità dei materiali e supporti della grafica pongono non poche sfide in termini di competenze, tempo e budget. L’assenza, di strumenti, standard e criteri dedicati e condivisi – a livello nazionale e internazionale – finisce con il generare una varietà di situazioni e soluzioni individuali basate sull’adattamento di strumenti nati con scopi o per tipologie di materiali differenti. In questo quadro, l’adozione di tools e approcci professionali – per esempio quelli bibliotecari – non garantisce di per sé gli esiti migliori dal punto di vista della catalogazione del progetto.
Il digitale può offrire ottime possibilità per accedere e mettere in rete patrimoni che sono dispersi presso varie sedi con missioni diverse. La promozione di una attiva collaborazione fra i vari soggetti che conservano e gestiscono diversi tipi di documenti e media, e la condivisione di strumenti e standard sono per ciò fondamentali. Solo per fare una ipotesi, si potrebbe per esempio realizzare un portale dedicato alla storia del design editoriale in Italia attingendo a metadati e immagini che provengono da biblioteche, archivi e collezioni di musei specialistici.
In questa immagine, un record del catalogo online del fondo personale John Alcorn attualmente affidato al Centro APICE – Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale. Quando, in fase di catalogazione, i curatori hanno dovuto decidere cosa digitalizzare, la scelta è stata di privilegiare i disegni originali di Alcorn, considerando che le copertine dei libri e dei materiali pubblicati era più facilmente reperibile da altri cataloghi o fonti. In questo catalogo le immagini, a bassa risoluzione, sono esplorabili solo attraverso la interfaccia del software adottato (xDams).
Per quanto riguarda la digitalizzazione, mentre una riproduzione esaustiva è chiaramente impensabile, si pongono altri problemi. Da un lato le istituzioni non specializzate sul progetto/design renderanno al più disponibili riproduzioni con finalità illustrativa, che possono essere di poco aiuto per le attività di studio. Dall’altro lato, istituzioni dedicate che provvedano alla digitalizzazione con finalità di conservazione del progetto/design non necessariamente renderanno i documenti accessibili e liberamente utilizzabili.
La carenza di fondi, staff e tempo è uno dei grandi problemi per la catalogazione e digitalizzazione del graphic design. L’Herb Lubalin Study Center of Design and Typography non fa eccezione. Qui non esiste neppure un inventario aggiornato, tuttavia la visita dell’archivio compensa i ricercatori con la possibilità di esplorare, toccare e prendere in mano i materiali ivi conservati. Per quanto riguarda le risorse digitali, la enfasi che il centro ha posto sull’accesso ha portato i curatori a fare un utilizzo intelligente di Internet. Oltre a una pagina istituzionale, il Center ha suoi profili Twitter e Instagram e un photostream Flickr che viene utilizzato per condividere e far circolare immagini e informazioni sui materiali dell’archivio, e dunque per attirare nuovi visitatori. Come spiegato dall’attuale curatore Alexander Tochilovsky, tutti questi social media, che hanno una interfaccia e sistemi di tagging facilitati, hanno un buon seguito fra i designer e gli appassionati. Gli scatti sono fatti internamente dallo staff, nel tempo libero, senza criteri particolari ma cercando di presentare i materiali più inediti e meno noti. Le immagini possono essere scaricate, o almeno questa è l’intenzione, a risoluzione web.
La questione dei diritti rimane – o comunque questo è quello che dichiarano le istituzioni – cruciale rispetto allo sviluppo e sperimentazione di risorse digitali. Il problema è particolarmente sentito laddove si ha a che fare con gli archivi personali – i cui diritti non sempre sono detenuti dalle istituzioni incaricate di ordinarne e conservarne i fondi. Le previsioni normative sono diverse nei vari paesi, la politica del fair use non è da tutti accolta e sono relativamente poche le istituzioni che si siano avventurate nel terreno dei Creative Commons.
In vista della riapertura nel 2015, il Cooper-Hewitt National Design Museum, Smithsonian Institution, New York, ha adottato un approccio radicale per migliorare e arricchire l’esperienza dei suoi visitatori reali e virtuali. Fra le altre iniziative, il museo non solo sta completando la digitalizzazione delle sue collezioni, accessibili online, ma ha deciso di rendere disponibili anche tutti i metadati e le concordanze – attraverso la piattaforma GitHub – secondo una licenza CC0. Inoltre il dipartimento Digital & Emerging Media ha progettato e rilasciato alcuni strumenti e risorse per sviluppatori e designer che vogliano dedicarsi a lavorare su nuovi formati di presentazione di quei dati. Di fronte a una simile disponibilità di dati e risorse, che cosa possono fare gli storici del design? Che cosa sono in grado di fare da soli? Con chi dovrebbero collaborare?
In breve, studiare il graphic design attraverso fonti e risorse digitali può portare a incontrare un paesaggio difforme e povero di possibilità.
Certo, qualcuno potrebbe voler rimarcare che per studiare la grafica nulla vale come l’esperienza diretta, maneggiare i materiali, scoprire relazioni inattese immergendosi fra faldoni e rotoli. Tuttavia – a parte il fatto che il graphic design non esiste solo per la stampa e non ha solo a che fare con supporti analogici, e su questo tornerò poi – la questione non è sostituire una modalità di accesso e studio a un’altra, ma capire se e come diverse modalità d’utilizzo, fisico e digitale, on site e off site possono sostenersi e integrarsi.
Un ulteriore aspetto che ostacola e limita le potenzialità d’utilizzo delle risorse digitali per lo studio del graphic design risiede nel fatto che, anche laddove si proceda a digitalizzare i documenti, in generale gli approcci e strumenti di descrizione e produzione di metadati rimangono sostanzialmente basati su testi e parole, con qualche rara eccezione per quanto riguarda, per esempio, gli aspetti cromatici. Per il graphic design appare altrettanto valido e urgente quello che ha osservato Brian Maidment – studioso di storia della stampa e della tradizione grafica – in merito allo studio della storia delle immagini e della cultura visuale nel contesto digitale: non solo è necessario implementare vocabolari specializzati per descrivere i contenuti visivi e gli elementi astratti della composizione visuale, ma è anche importante cominciare a pensare nuove modalità e approcci per analizzare e descrivere i documenti visivi, che vadano oltre le precise risposte che possono venire da una ricerca basata su parole o su categorie prefissate.3
Per affrontare questa come le altre sfide, d’altra parte, è necessaria la collaborazione e convergenza di interessi e competenze di soggetti diversi, dalle istituzioni ai ricercatori e studiosi, ai graphic designer. Rimane in definitiva sempre valido quanto scriveva de Smet alla fine del suo articolo “tout est possible. Affaire de décision, d’organisation, d’action. L’affaire de tous aussi”: è un affare che riguarda tutti quanti sono interessati, e sta alla loro intenzione e azione fare in modo che il graphic design cessi di essere una specie di fantasma che si aggira fra gli archivi.
(Vedi gli articoli correlati.)
Note
- Si veda Jeffrey Schnapp,“Animare l’archivio / Animating the archive”, in Design & cultural heritage, vol. 2: Archivio animato / Animated archive, edited by Fulvio Irace e Graziella Leyla Ciagà, Milano: Electa, 2013, pp. 63-80. ↵
- Apparso originariamente in Graphisme en France, Paris: Centre national des arts plastiques, 2007, l’articolo si trova ora in Catherine de Smet, Pour une critique du design graphique: Dix-huit essais, Paris: Éditions B42, 2012, pp. 48-53. Per la situazione italiana si veda Fiorella Bulegato, “La grafica italiana negli archivi”, in Grafica, storia, Italia / Graphic design, history, Italy, numero 24 di Progetto grafico, a cura di Maddalena Dalla Mura e Carlo Vinti, 2013, pp. 92-105. ↵
- Si veda Brian Maidment, “Writing history with the digital image: A cautious celebration”, in Toni Weller (ed.), History in the digital age, Routledge, 2013, pp. 111-126. ↵